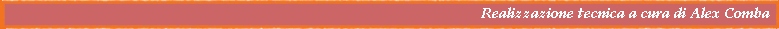|
| |
“…La lingua non è stata
un problema perché fin da piccolo i nonni mi...(continua)" |
|
 |
| |
“...Per me è stato difficile, l’apprendimento
della lingua, perché a quei tempi...(continua)" |
|
 |
| |
“…La mia famiglia si è trovata
bene in Francia, mio padre ha imparato a scrivere...(continua)"
|
|
 |
| |
“…La
fame ci tormentava, così, nel tardo pomeriggio, io e il mio
compagno...(continua)" |
|
 |
| |
“…Non ho mai sofferto di nostalgia. Scrivevo
abbastanza sovente ai miei, ed ero...(continua)"
|
|
 |
| |
“…Pragelato ha mantenuto le sue tradizioni
in virtù del fatto che questi emigranti...(continua)" |
|
 |
| |
In questa sottosezione puoi leggere alcuni documenti
ed articoli inerenti alla sezione corrente |
|
 |
| |
“…Negli Anni ’30 dei sacerdoti della
Valle, come Don Lantelme, Don Samuel, Don Berger, avevano...(continua)" |
|
|
| |
Accoglienza e Problemi |
|
| |
Il tipo di accoglienza riservato dai francesi agli
emigranti delle nostre Valli, in parte variò nel tempo, a causa
degli eventi politici che videro le due nazioni alleate o nemiche.
Nel primo periodo gli emigranti italiani erano ben tollerati e in
particolare i piemontesi potevano aspirare a impieghi più remunerativi,
ad essi era aperta la possibilità di passare da un modesto
lavoro ad una attività economica più soddisfacente.
Molti da semplici boscaioli divennero commercianti di legname, altri
da braccianti divennero proprietari di fattorie, alcuni aprirono piccoli
negozi, altri ancora fecero carriera all’interno dei grandi
alberghi. A ciò concorrevano alcuni fattori come la lingua
e in certi casi un buon livello culturale.
Alex
Berton, classe 1933:
 “…
La lingua non è stata un problema perché fin da piccolo
i nonni mi parlavano in patuà, e mia zia e mia mamma in francese.
[…] “…
La lingua non è stata un problema perché fin da piccolo
i nonni mi parlavano in patuà, e mia zia e mia mamma in francese.
[…]
I pragelatesi non si distinguevano dagli abitanti del posto, la
lingua era acquisita e il livello culturale era in media più
alto di quello dei francesi. In Francia si ricostituiva una comunità,
il direttore di ristorante, quello di sala si portavano tutto il
loro personale, così pure il portiere ... Se avevi ambizioni
di carriera transitavi da un albergo ad un altro a seconda di cosa
ti conveniva…”
|
|
| |
|
|
| |
Tuttavia i primi tempi furono difficili per tutti,
anche chi si adattò molto presto alla nuova situazione ricorda
problemi ed episodi di emarginazione.
Franco
Prinzio, classe 1930,
era partito dalla bassa Valle, da Villar Perosa e le cose per lui
erano diverse:
“... Per me è stato difficile
l’apprendimento della lingua, perché a quei tempi in
Piemonte si parlava solo nel dialetto locale, ed io quindi conoscevo
in modo molto approssimativo e poco corretto l’italiano. Vedevo
la differenza tra me ed i miei amici toscani: loro parlavano il
francese correttamente, come d’altronde facevano con l’italiano.
Insomma, io ho avuto un po’ più di difficoltà,
per l’accento in particolare.
Le prese in giro sono durate molto poco anche nella fornace dove
lavoravo. Sì, ogni tanto: – Ehi, macarony! –,
mi sentivo dire, ma erano cose cui non davo peso. Inoltre, acquisita
la lingua, non c’era più differenza. Io andavo a ballare,
ho avuto fidanzate, andavo ad imparare a nuotare… Mi sono
trovato bene, ho fatto una buona esperienza di emigrazione…”
|
|
| |
|
|
| |
Marta Valletti,
classe1936, bambina ricorda i primi tempi in Francia:
 “…
La mia famiglia si è trovata bene in Francia, mio padre ha
imparato a scrivere il francese e lo parlava benissimo, senza accento
italiano; parlava anche il “patuà” del posto,
il provenzale, che assomiglia molto al piemontese. Tuttavia i primi
tempi sono stati un po’ difficili: ci dicevano: “ Venite
a mangiare il nostro pane!”. "Les transalpin qui viennent
manger nôtre pain". “…
La mia famiglia si è trovata bene in Francia, mio padre ha
imparato a scrivere il francese e lo parlava benissimo, senza accento
italiano; parlava anche il “patuà” del posto,
il provenzale, che assomiglia molto al piemontese. Tuttavia i primi
tempi sono stati un po’ difficili: ci dicevano: “ Venite
a mangiare il nostro pane!”. "Les transalpin qui viennent
manger nôtre pain".
… Dopo è cambiato perché all’emigrazione
italiana sono succedute quella spagnola, portoghese e adesso algerina
e dall’Est europeo. Comunque per gli italiani è stato
più facile inserirsi perché arrivavano da paesi che
avevano la stessa religione dei francesi e una cultura e modi di
vita simili, anche la lingua tutto sommato non era un ostacolo molto
grande. […]
A sei anni sono andata a scuola, non sapevo parlare il francese,
in casa parlavamo solo piemontese, il francese lo usavamo solo con
i francesi. Ero tutta timida e a disagio perché non capivo
e non sapevo rispondere. Noi italiani ci chiamavano “babì“,
“macaronì”. Nel periodo in cui è emigrato
mio padre non eravamo ben visti, mi ricordo che mi canzonavano “la
babì, la babì”…”
Come sottolinea Marta Valletti,
le persone che emigravano dalle Valli avevano il vantaggio di spostarsi
in un paese col quale avevano in comune tradizioni, religione e
spesso anche la lingua, infatti il provenzale era parlato quasi
ovunque ed è molto simile al francese, in alta Valle, poi,
si parlava direttamente il francese. Storicamente la val Chisone
e la val Germanasca erano state più volte comprese nel territorio
francese e mai si erano interrotti i contatti commerciali, tant’è
che l’alta Valle nella prima metà del Novecento continuava
a gravitare su Briançons, più che su Pinerolo.
|
|
| |
|
|
| |
Una maggiore ostilità verso gli emigranti italiani
si ebbe invece a verificare con l’escalation della politica
espansionistica fascista e lo scoppio della guerra. Tuttavia gli antichi
vincoli, cementati da secoli di migrazioni, costituirono una rete
di solidarietà che non si lacerò completamente neanche
con lo scoppio della guerra. Durante uno dei più feroci rastrellamenti
nazifascismi ( agosto 1944 operazione “Nachtigall”) che
ebbe come teatro le valli Chisone e Susa circa trecento partigiani
trovarono rifugio in Francia nel Queiras.
La testimonianza di Franco Campo,
classe 1926, partigiano di Villar Perosa:
 “…
La fame ci tormentava, così, nel tardo pomeriggio, io e il
mio compagno decidemmo di uscire per il paesino di le Roux, alla
ricerca di qualcosa da mettere sotto ai denti. “…
La fame ci tormentava, così, nel tardo pomeriggio, io e il
mio compagno decidemmo di uscire per il paesino di le Roux, alla
ricerca di qualcosa da mettere sotto ai denti.
Bussammo ad una porta, venne ad aprirci una donna che in piemontese
ci chiese cosa volessimo. Era infatti originaria del cuneese. Alle
sue spalle si intravedeva la tavola apparecchiata per due e in un
angolo il focolare, sul quale borbottava una pentola. Un uomo fumava
la pipa seduto lì accanto, sembrava pensieroso e non si era
per nulla scomposto alla nostra vista.
Noi dunque, rispondemmo alla donna nel modo più gentile possibile,
chiedemmo per favore un piatto di minestra, il cui profumo ci sollecitava,
se mai ce n’era ancora bisogno, l’appetito.
Ella ci osservava, i volti provati dalle notti insonni e dalla paura,
la magrezza dei nostri corpi parlavano per noi.
La donna si volse interrogativamente verso il marito, lui alzò
gli occhi e il suo sguardo si fece duro, scosse la testa e disse:
“No e poi no, ci hanno fatto la guerra!”
Allora con passo fermo la moglie si avvicinò all’uomo,
lo afferrò per le spalle e lo scosse con violenza.
- Dì un po’ cosa ti passa per la testa?-
- Pensa a nostro figlio disperso su nelle Fiandre. Forse proprio
in questo momento sta bussando alla porta di una casa sconosciuta,
come fanno questi ragazzi, forse anche lui sta elemosinando un po’
di cibo… Vorresti che gli voltassero le spalle, che gli chiudessero
la porta in faccia?-
Dalle sue parole, ma soprattutto dal tono della voce e dal portamento,
traspariva una determinazione che l’uomo non seppe o non volle
contrastare.
Abbassò il capo e ci fece cenno di entrare.
Ci fu dato un piatto di minestra caldo e poi la pentola da ripulire
ben bene, fino in fondo…”
|
|
| |
|
|
| |
Bruno Enrico,
classe 1932, che ebbe esperienze di emigrazione prima e dopo la seconda
guerra mondiale dice:
“… La Francia che ritrovammo
nel dopoguerra, non era più la Francia di prima: ora eravamo
malvisti; del resto ai francesi nel ‘40 avevamo dato una pugnalata
alla schiena, ma non tutti eravamo colpevoli …”
Franco Prinzio aggiunge:
“… In Francia ci prendevano
in giro, dicendo: – Voi vi siete venduti all’America,
noi invece andiamo avanti da soli… – Queste cose mi
sono state dette dal momento che mi vantavo di arrivare da un paese
dove non c’era più la tessera del pane e dove si mangiava
grazie agli americani. Questo ai francesi dispiaceva un po’!
…”
Concorda anche la testimonianza di Aldo
Roventi Beccari, classe 1930:
“… Venni accolto in modo
cordiale anche se essere italiani, particolarmente allora, in Francia,
non era considerato un gran pregio…”
Alcuni, come il padre di Marta Valletti, soffrivano profondamente
di nostalgia per il proprio paese e ci tornavano regolarmente, in
inverno o quando il lavoro lo consentiva; altri, come la madre di
Marta, si rifiutarono di tornarci, forse perché cancellarlo
dalla memoria poteva alleviare la sofferenza del distacco o perché
nel tempo era maturato un sentimento di rabbia
verso il luogo che non aveva saputo offrire la possibilità
di una vita decorosa ai propri figli.
Marta Valletti:
“… Mio papà soffriva
di nostalgia, mia mamma no: mia madre ha lasciato qui sua madre
e non è mai più tornata a trovarla, mio padre invece
tornava tutti gli anni a Perrero.
A casa di mia nonna ho trovato le lettere che mia madre scriveva
alla sua in cui diceva che era molto felice in Francia, avevano
avuto un buon raccolto, mettevano da parte molti soldi, …ma
non era vero niente; non si erano arricchiti, semplicemente vivevano
meglio…”
Aldo Roventi Beccari:
 “…La
cosa peggiore era la lontananza da casa e la nostalgia che ogni
sera mi assaliva: il mio sogno era pur sempre tornare a casa con
un sacco di soldi!…” “…La
cosa peggiore era la lontananza da casa e la nostalgia che ogni
sera mi assaliva: il mio sogno era pur sempre tornare a casa con
un sacco di soldi!…”
|
|
| |
|
|
| |
Franco Prinzio
sente meno la mancanza della propria casa, il suo racconto aggiunge
particolari rispetto alla comunità italiana in Francia:
“… Non ho mai sofferto di
nostalgia. Scrivevo abbastanza sovente ai miei, ed ero felice. Mi
sono trovato in un bel posto. Ho potuto da subito comprarmi una
bicicletta; frequentavo l’Oratorio, perché i miei parenti
erano molto religiosi. La prima cosa che mi hanno detto è
stata: – Qui, la domenica si va a messa e poi all’Oratorio.
– Era quasi un obbligo, ma lo facevo volentieri, perché
sapevo di far contenti i miei parenti. La religione a Marsiglia
era un po’ trascurata, noi abbiamo esportato lì la
religiosità, l’attaccamento alla Chiesa. Non eravamo
fanatici, però noi alla domenica, come si usava fare qua,
continuavamo ad andare a Messa.
Per il resto ero in piena libertà…”
Una grande città come Marsiglia, poteva diventare molto
pericolosa per un giovane emigrante, ben lo sapevano le famiglie
che accoglievano i nuovi arrivati e che non mancavano di metterli
in guardia contro tali pericoli.
Franco Prinzio:
“… Negli anni in cui ho vissuto
in Francia sono stato ospitato da una zia vedova che si occupava
di me come fossi stato suo figlio, aveva solo una grossa paura:
sapeva che io ero solo ed arrivavo da un piccolo paese del Piemonte,
trovandomi in una grande città, Marsiglia, avrei potuto trovare
cattive compagnie. Già in quel periodo c’erano delle
persone poco affidabili, la preoccupazione dei miei parenti era
quella. […]
Per esempio, in una zona non molto lontana da quella dove vivevo,
che si chiama “La Juliette”, arrivano i carichi dall’Italia
di arance, sapevo che ogni tanto delle persone, di notte, andavano
ed aprivano il vagoni dove erano contenuti i frutti, anche solo
per veder cadere giù le arance ed io ho sempre cercato di
restarne alla larga.
Se avessi sbagliato, sarei finito dai gendarmi, e siccome “i
documenti parlano chiaro”, sarei stato rimpatriato sicuramente…”
|
|
| |
|
|
| |
Le testimonianze concordano nell’affermare che
gli emigranti tendevano a ricostituire nel nuovo paese delle piccole
comunità, all’interno delle quali probabilmente si sentivano
più sicuri, ma che rendevano più difficile il processo
di integrazione.
Per quanto riguarda l’emigrazione stagionale tale processo non
si avviò mai o si risolse in atteggiamenti di facciata se Alex
Berton afferma:
 “…
Pragelato ha mantenuto le sue tradizioni in virtù del fatto
che questi emigranti andavano, guadagnavano e riportavano grandi
risorse. Al momento in cui rientravano nel paese si riappropriavano
della cultura locale. La donna che andava a lavorare all’estero
partiva vestita in costume, si cambiava “a la mode”
alla stazione di Oulx o di Cesana (dove partivano i treni e i pullmann)
faceva la sua stagione e rientrava cambiandosi di nuovo a Oulx o
Cesana per poter rientrare nelle sue tradizioni: “c’mà
la ventia” (come si conviene)…” “…
Pragelato ha mantenuto le sue tradizioni in virtù del fatto
che questi emigranti andavano, guadagnavano e riportavano grandi
risorse. Al momento in cui rientravano nel paese si riappropriavano
della cultura locale. La donna che andava a lavorare all’estero
partiva vestita in costume, si cambiava “a la mode”
alla stazione di Oulx o di Cesana (dove partivano i treni e i pullmann)
faceva la sua stagione e rientrava cambiandosi di nuovo a Oulx o
Cesana per poter rientrare nelle sue tradizioni: “c’mà
la ventia” (come si conviene)…”
|
|
| |
|
|
| |
| I
contatti con i paesi di origine rimangono forti, non solo
a livello famigliare, ma anche associativo; leggiamo sull’Eco
del Chisone del 5 febbraio 1921, cronaca di Pragelato:
|
|
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
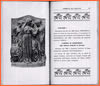 |
|
|
Sorgono in
Italia associazioni volte a sostenere gli emigranti e
ad evitare loro esperienze spiacevoli, come la già
citata “Opera Bonomelli” |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Anche a livello locale nascono
iniziative volte a istruire i possibili emigranti rispetto
alle norme relative all’espatrio. Vengono fornite
informazioni sui paesi di destinazione. A Perrero, nell’ottobre
del 1920, è istituito un comitato per l’assistenza
e la tutela degli emigranti proprio con queste finalità.
|
|
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Sullo stesso tema Alex
Berton nella sua intervista
ricorda:
“… Negli Anni ’30 dei
sacerdoti della Valle, come Don Lantelme, Don Samuel, Don Berger,
avevano istituito un’organizzazione con sedi a Parigi, Lione
alla quale potevano rivolgersi le ragazze e i giovani emigranti,
per avere indicazioni, suggerimenti ed aiuti per qualsiasi evenienza.
Era nata soprattutto per le donne, affinché non si trovassero
in una città sconosciuta completamente abbandonate. Questo
per dare un’idea della mentalità del tempo…”
 L’emigrante
quando rientrava si sentiva in dovere di raccontare, di dire quello
che aveva vissuto, quello che aveva passato. Ritrovava le sue tradizioni,
arrivava con del denaro e molte esperienze di vita. Gli emigranti
pragelatesi che lavoravano nei grandi alberghi vivevano il viaggio
di ritorno come una vera e propria festa: si fermavano in alberghi
meno lussuosi e giocavano a invertire i ruoli: ora erano loro che
si facevano servire! Tornati a casa organizzavano battute di caccia,
a settembre partivano col cavallo e portavano giù a Pinerolo
tre o quattro quintali di patate, un po’ di segale e così
via, ma soprattutto con i soldi guadagnati acquistavano vino, mele,
pere, castagne, farina. L’emigrante
quando rientrava si sentiva in dovere di raccontare, di dire quello
che aveva vissuto, quello che aveva passato. Ritrovava le sue tradizioni,
arrivava con del denaro e molte esperienze di vita. Gli emigranti
pragelatesi che lavoravano nei grandi alberghi vivevano il viaggio
di ritorno come una vera e propria festa: si fermavano in alberghi
meno lussuosi e giocavano a invertire i ruoli: ora erano loro che
si facevano servire! Tornati a casa organizzavano battute di caccia,
a settembre partivano col cavallo e portavano giù a Pinerolo
tre o quattro quintali di patate, un po’ di segale e così
via, ma soprattutto con i soldi guadagnati acquistavano vino, mele,
pere, castagne, farina.
|
|
| |
|
|
| |
Chi tornò lo fece perchè costretto da
motivi contingenti come lo scoppio della seconda guerra mondiale.
Alex Berton:
“… Siamo poi ritornati in
Italia alla fine di agosto del 1939, siamo venuti via prima perché
c’era stata la dichiarazione di guerra tra la Francia e Germania
e Vittel era in Alsazia, dove c’ era la linea Maginot. Il
direttore dell’albergo aveva consigliato mio papà di
rientrare, “non ci sarà la guerra tra i nostri due
paesi, ma è opportuno che tu rientri”. L’anno
successivo mio papà avrebbe dovuto prendere la direzione
dell’albergo, ma purtroppo la guerra era scoppiata anche tra
Italia e Francia e non siamo più tornati. Siamo rientrati
con il sig. Marauda di Luserna San Giovanni che aveva una Augusta,
quelle macchine che avevano l’aquila davanti sul cofano e
faceva il servizio di autista a Vittel…”
|
|
| |
| |
|
| Trascrizione della Lettera |
| Vittel,
13 gennaio1940 |
Signor Celestino Berton
Pragelato
Provincia di Torino ( Italia )
Mio Caro Berton,
ho ricevuto la vostra gradita lettera del 28 ultimo
scorso che mi inviava i vostri migliori auguri per il
1940; vi ringrazio e vi prego di accettare i miei in
cambio.
Per quel che riguarda la stagione 1940, niente è
deciso fino al presente.
Non ci resta che il GRAND HOTEL e l’ERMITAGE e
questi due hotels, ma, essendo situati nella zona dei
soldati, il loro utilizzo sarà certamente paralizzato.
Tuttavia credo che saremo prenotati all’inizio
di Febbraio e, se c’è la possibilità
di riservarvi i vostri posti precedenti, lo farò
molto volentieri.
Augurando che il 1940 ci porti la Vittoria, una pace
definitiva e l’amicizia dell’Italia, vi
invio, mio caro Berton e Signora, i miei migliori saluti.
Direttore Generale del GRAND HOTELS
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Molti valligiani rimasero per sempre in Francia e
divennero cittadini francesi a tutti gli effetti, come altre migliaia
di emigranti di nazionalità diverse.
Questo fatto ci induce a riflettere sul significato odierno di
“italiano”, “francese”, “marocchino”…
e ci suggerisce un’idea di comunità aperta, dove vi
è possibilità di sviluppo e di vero progresso per
tutti, a patto che tutti condividano i valori legati alla dignità
dell’uomo e al rispetto reciproco tra culture diverse.
Ancora oggi molti abitanti delle valli Chisone e Germanasca hanno
parenti francesi, alcuni di questi hanno qui una casa, tornano per
le vacanze, ma ormai si tratta di cugini di terzo, quarto grado
e i legami si vanno affievolendo.
|
|
| |
|
|
|