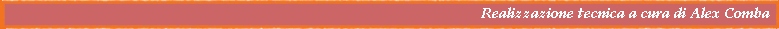|
| |
“...Giuseppina Reynaud, nata a Pramollo,
nel 1899, è andata a fare la balia in...(continua)" |
|
 |
| |
Sono emigrato nel luglio del 1948 e sono andato in
Francia , nella Normandia nel...(continua)" |
|
 |
| |
Il signor Breuza Enrico, padre di Attilio, è
emigrato in Francia nel 1929 ed è tornato...(continua)" |
|
 |
| |
Nei primi decenni del ‘900 Pragelato contava
circa 1500 abitanti, c’era...(continua)" |
|
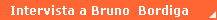 |
| |
Il mio trisnonno partiva da Porte per andare a piedi
fino in Francia a lavorare come...(continua)" |
|
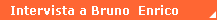 |
| |
“Monterimar” : il paese del torrone (adesso
lì vicino hanno costruito una centrale...(continua)" |
|
 |
| |
La mamma e il papà della signora Ester, la
mia vicina di casa, sono emigrati in...(continua)" |
|
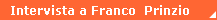 |
| |
Io sono emigrato nel 1947, a fine guerra. La Francia
aveva bisogno di...(continua)" |
|
 |
| |
Mi ricordo che i miei si sono sposati verso il 1920
e poi sono emigrati...(continua)" |
|
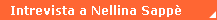 |
| |
Sappe’ Adolfo e Long Luigia, i genitori di mia
nonna Nellina, sono...(continua)" |
|
 |
| |
La famiglia di mio padre era composta da tre sorelle
(Marietta madre...(continua)" |
|
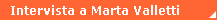 |
| |
Sono emigrata in Francia nel 1938 a gennaio. Mio padre
si chiamava Albino e...(continua)" |
|
|
| |
Le Fonti - INTERVISTE |
|
| |
INTERVISTA a Alda Jahier classe 1932 Pramollo
(To) |
|
| |
“… Giuseppina Reynaud, nata a Pramollo,
nel 1899, è andata a fare la balia in Francia.
Aveva lasciato qui a Pramollo il suo primo figlio ed era andata ad
allattare il neonato di una ricca famiglia di Parigi; i soldi che
le davano li spediva alla famiglia.
Per molti anni è rimasta “al servizio” di quella
famiglia, facendo tanti lavori.
Come lei hanno fatto molte donne di Pramollo…”
|
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Aldo Roventi Beccari classe 1930
Pinasca (To) |
|
| |
Sono emigrato nel luglio del 1948 e sono andato in
Francia , nella Normandia nel paese di Cuy Saint Fiacre.
Decisi di emigrare perché ero il primo di tre fratelli, andai
in cerca di lavoro, riuscii ad avere questa opportunità tramite
un amico che era già occupato in una cascina.
Partii da solo all’età di 18 anni, sapendo di dovere
rientrare in Italia per il Servizio Militare, vi restai per due anni,
sino al 1950, risultavo quindi già “renitente alla leva”.
Per espatriare serviva il passaporto, la carta di soggiorno e la carta
di lavoro che dovevano essere richiesti tramite il consolato italiano.
Il viaggio fu abbastanza complicato:
Dubbione – Pinerolo con il “tram way - Gibuti”
Pinerolo –Torino in treno
Torino – Parigi in treno
Parigi – Gournay en Bray con una specie di treno locale
Gournay en Bray - Cuy St. Fiacre (la cascina ovviamente era in mezzo
alla campagna in località Ferme le Quesnoy) in automobile.
Da Dubbione partii abbastanza presto al mattino ed arrivai a Parigi
il mattino seguente, ma arrivai a destinazione solamente alla sera
per l’ora di cena.
Durante i due anni di permanenza non cambiai mai le mie mansioni,
ero il “sartiè” cioè l’addetto ai
cavalli che erano impiegati ad arare, seminare, mietere, trainare
i carri, ecc.
Quindi facevo anche lo stalliere, e al pomeriggio si provava a guidare
il trattore (il primo che abbia mai visto).
Bisogna pensare che era finita da poco la 2° guerra mondiale,
a Dieppe, distante circa 30 km dalla fattoria, erano sbarcati gli
alleati, la Francia stava lentamente tentando di ricominciare a vivere
in un modo normale.
La paga sinceramente non mi sembrava un granchè: per 5000 franchi
al mese, compresi vitto e alloggio, dovevo lavorare dalle 5 del mattino
alle 10 di sera di tutti i giorni dell’anno, tranne una settimana
di vacanze.
L’alloggio era fornito dai proprietari ed era una stanza senza
servizi in una specie di magazzino per gli attrezzi freddo e polveroso.
Venni accolto in modo cordiale anche se essere italiani, particolarmente
allora, in Francia, non era considerato un gran pregio.
Non capivo il francese, ma non era così lontano dal dialetto
piemontese, dovetti imparare a parlare mentre lavoravo.
Il clima del posto non mi piaceva perché era molto umido, in
particolare in inverno c’era sempre la nebbia.
La cosa che più apprezzavo era poter lavorare gestendomi autonomamente,
ovviamente dovevano esserci i risultati a fine giornata; la cosa peggiore
era la lontananza da casa e la nostalgia che ogni sera mi assaliva:
il mio sogno era pur sempre tornare a casa con un sacco di soldi!
A casa mio padre era rimasto vedovo qualche anno prima e lavorava
alla RIV di Villar Perosa, mio fratello, di due anni più giovane
di me, e mia sorella, di nove anni più giovane di me, erano
stati affidati alle famiglie di due zie materne.
Sono rientrato in Italia per il servizio militare e non sono mai più
tornato a Cuy Saint Fiacre. |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Attilio Breuza classe 1925, Salza
(To) |
|
| |
Il signor Breuza Enrico, padre di Attilio, è
emigrato in Francia nel 1929 ed è tornato nel 1942, in seguito
allo scoppio della guerra.
È emigrato perché non trovava lavoro.
Si è trovato molto bene perché là aveva dei suoi
parenti .
È’ partito da Fontane, a piedi, ed ha raggiunto
la Francia passando dal colle d’Abries.
A Marsiglia vendeva legna e carbone, prima come dipendente, in seguito
aprendo un negozio in proprio.
Dopo è emigrata la signora Giulia Breuza, la mamma di Attilio,
nel 1932; si è spostata in
treno.
Attilio è emigrato nel 1933, aveva otto anni.
Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, gli italiani non erano
ben accettati dato che
erano alleati con i Tedeschi, perciò al signor Enrico avevano
ritirato la licenza per vendere
legname, per questo motivo lui, la moglie e il figlio sono tornati
in Italia; Attilio aveva
diciassette anni quando sono tornati. |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Alex Berton classe 1933 Pragelato
(To) |
|
| |
Nei primi decenni del ‘900 Pragelato contava
circa 1500 abitanti, c’era un problema di sovrappopolazione.
Nella prima metà del ‘900 nell’alta Valle (da Sestrieres
fino a Bec Daufin) si viveva di poco, di prodotti locali. Si trattava
di una realtà esclusivamente agricola ( fatta eccezione per
le miniere del Beth ormai in fase di smantellamento): si coltivavano
segale, orzo, avena, patate; si allevava bestiame che, oltre a dare
aiuto nei campi,forniva carne, latte, formaggi…
Si consideri che ogni frazione di Pragelato aveva una portata bovina
di 20 capi e che le frazioni erano 19; ogni famiglia aveva due o tre
capi di bestiame bovino, c’era il mulo, l’asino o il cavallo
e 4 o 5 pecore, uno o due maiali, quindi di cibo ce n’era, ma
le risorse erano insufficienti per il numero di persone.
Si faceva fronte a necessità eccezionali con la vendita di
piante.
L’emigrazione, per lo più stagionale, aveva lo scopo
di integrare i proventi dell’agricoltura locale.
Vi erano pochissimi rapporti con la bassa Valle, il punto di riferimento
rimaneva sempre Chambéry, prima era stata Briançon,
fino al periodo degli Escartons.
Nel 1713, col passaggio alla casa Savoia, si mantenne la parlata francese
e le tradizioni locali, ma avvenne un graduale spostamento verso la
realtà savoiarda, è da lì che le nostre donne
recuperarono il costume. Ed è proprio verso queste regioni
che si dirigevano i pragelatesi.
I bisnonni e i nonni avevano alle spalle un’emigrazione limitata
nel tempo, che si occupava in lavori manuali pesanti, mentre con
la generazione di mio padre (Anni ’20 – ‘30) si
determinò progressivamente un'emigrazione legata all’attività
alberghiera. Fu interessato principalmente Pragelato, ma in modo
diverso coinvolse anche Usseaux e Champlas du Col. Da questi paesi
partiva manodopera che veniva impiegata come barman, vendevano caldarroste
o lavoravano nelle “brasserie”. Nella realtà
di Champlas du Col e di Cesana si trattava piuttosto di un esodo
definitivo, si andava a lavorare nelle fabbriche di biciclette,
nelle coltivazioni di tabacco. La situazione era totalmente diversa,
le famiglie erano più numerose e il gruzzolo serviva per
sistemarsi in Francia.
A Pragelato era dunque l’epoca dei grandi alberghi, era un
tipo di emigrazione che coinvolgeva l’80% della popolazione.
Il flusso dei pragelatesi si dirigeva su Marsiglia, Cannes, Nizza,
ma più massicciamente sulla Savoia: Chambery, Annecy, Aix-
Le- Bain, Evian o Parigi, Dihar, Vittel.
Le donne invece emigravano come balie, governanti, donne di compagnia
in famiglie nobiliari.
Pragelato ha mantenuto le sue tradizioni in virtù del fatto
che questi emigranti andavano, guadagnavano e riportavano grandi
risorse. Al momento in cui rientravano nel paese si riappropriavano
della cultura locale. La donna che andava a lavorare all’estero
partiva vestita in costume, si cambiava “a la mode”
alla stazione di Oulx o di Cesana (dove partivano i treni e i pullmann)
faceva la sua stagione e rientrava cambiandosi di nuovo a Oulx o
Cesana per poter rientrare nelle sue tradizioni: ”c’mà
la ventia” (come si conviene).
L’emigrazione di questo tipo forniva ad ogni famiglia una
notevole entrata, un guadagno inimmaginabile per l’epoca,
se consideriamo il fatto che allora la Lira valeva più del
Franco francese.
Negli anni 1928-’29 si riusciva già a portare a casa
un corrispettivo di 150.000 / 200.000 lire per persona, mio papà
e mia mamma con questo tipo di lavoro si sono fatti la casa.
Ci sono famiglie che hanno realizzato, comprato, costruito e ci
sono famiglie che invece hanno capitalizzato e si sono ritrovate
con 400 - 300 mila lire con cui, allora, era possibile acquistare
tre o quattro cascine di Pinerolo. Dopo la guerra si sono trovati
con un capitale svalutato e li ha poi salvati la pensione dei coltivatori
diretti a 5.000 lire al mese. (Anno 1957/58) |
|
| |
|
|
| |
Mio padre è originario di Pragelato, la
sua famiglia aveva 4 o 5 ettari di terreno divisi in seminativi,
prati irrigui, bosco, il solito bestiame e qualche animale da cortile.
Egli era nato nel 1899, aveva un fratello e una sorella, il fratello
era più anziano e quindi è partito per primo, quando
poi è rientrato è partito mio padre e ha passato un
anno e mezzo in una famiglia inglese, dove faceva il valet, l’uomo
di fatica: puliva l’argenteria, le scale… La prima volta
che è emigrato poteva avere 12 anni, siamo nel 1911, e aveva
i soldi contati per arrivare in Inghilterra, aveva avanzato forse
5 lire o centesimi e li ha dovuti dare al fratello perché
potesse pagarsi il viaggio di ritorno. Dopodiché è
stato in Germania, ma per poco tempo, è rientrato a Pragelato
all’età di 15 – 16 anni, quindi ha fatto la grande
guerra. Durante questo periodo il flusso migratorio è diminuito,
ma non si è interrotto perché eravamo alleati della
Francia.
Ha poi cominciato a lavorare negli alberghi francesi e lui ha preso
il ramo ristorante e il servizio dei piani, all’inizio era
cameriere.
Sul posto di lavoro ha conosciuto mia madre che era di un paesino
nei pressi di Evian.
La prima volta che mia mamma è venuta a Pragelato era piuttosto
preoccupata perché mio papà le aveva parlato di un
paese di montagna, non è che nella sua realtà di paese
di pescatori si stesse molto meglio, comunque..
L’evento più tragico è avvenuto a Pinerolo,
dove hanno dovuto dormire in uno stallaggio, la Rosa Rossa, e mio
papà è uscito con gli amici. Lei è rimasta
sola in camera, sentiva i carrettieri bestemmiare e questo è
stato un dramma, non capiva cosa dicevano. Invece quando è
arrivata a Pragelato l’hanno accolta i parenti più
prossimi, suocero, suocera, cognata con una signora che parlava
squisitamente il francese, mio nonno inoltre insegnava il francese
nelle scuole. Le avevano già riservato una camera, avevano
organizzato un ricevimento all’ Albergo Albergian e dopo è
stata accompagnata in tutte le case della frazione. Invece al matrimonio
avevano partecipato solo i due papà.
Per l’alta Valle è iniziato il periodo dei matrimoni
con donne francesi.
Si sono sposati nel 1927, hanno costruito la casa dove ora vivo
io, era già finita negli anni 1929 – 1931 - 1932, pagata
con il solo introito di mance. Il nonno savoiardo, in seguito, ha
voluto comunque rendersi conto di com’era sposata la figlia,
quindi è partito senza dire niente a nessuno ed è
venuto nel paese, quando la figlia non c’era. Mia mamma era
già partita per la stagione estiva, lui aveva preso il treno
fino a Oulx e poi era venuto a piedi fino a Pragelato. Il consuocero
già lo conosceva, ma gli altri parenti no, tuttavia hanno
fatto festa una settimana . Tornato a casa ha detto alla moglie:
“ Elle est bien marie l’Angelique!” (Angelica
è ben sposata!)
Nel 1933 sono nato io, i bambini fino all’età di tre,
quattro, cinque anni rimanevano al paese e venivano assistiti dalle
zie o dai nonni, poiché la coppia giovane andava a fare la
sua stagione. Infatti quando gli uomini partivano normalmente in
paese rimanevano le donne e comunque i ragazzi fino a 14 –
16 anni.
Questa è stata anche la mia sorte: io ho sempre ammirato
la zia che mi ha allevato e che aveva per me un’affezione
particolare contraccambiata, ma non ha mai sostituito la mamma;
ci sono stati dei casi dove la zia o la nonna hanno sostituito definitivamente
il padre o la madre e questo ha causato dei traumi.
Diventati più grandicelli i figli seguivano i genitori oltre
confine.
Per le stagioni negli alberghi partivano normalmente ad aprile,
prima di Pasqua, poi si rientrava a fine agosto o ai primi di settembre,
alla fiera del 14 settembre di Soucère Haute tutti erano
rientrati quindi si faceva una grande baldoria, una grande festa
e grandi partite di caccia. |
|
| |
|
|
| |
Mi ricordo il mio distacco da Pragelato e quindi
da mia zia, la sorella di mio papà, dai nonni, avevo cinque
anni. Sono andato in taxi da Pragelato fino a Oulx , lì mi
hanno consegnato ad un’hostess e ho viaggiato fino a Vittel,
erano treni a carbone e mi ricordo che in una delle tante stazioni,
di notte, mi hanno passato un cuscino: per me era una cosa eccezionale
e mi hanno adagiato per dormire. Alla stazione mi aspettava la mamma
e una vita totalmente diversa da quella del mio paese. Sono stato
affidato a una famiglia che mi teneva in pensione. Il marito era
impiegato di una società delle acque minerali di Vittel,
mentre la signora era casalinga. La lingua non è stata un
problema perché fin da piccolo i nonni mi parlavano in patuà,
e mia zia e mia mamma in francese.
Mi accompagnavano a vedere papà e mamma due volte al giorno
in albergo, allora lui era direttore dei piani, lo vedevo verso
le 10,30 - 11, prima che incominciasse il servizio, quando già
si era tolto la divisa dal mattino per indossare quella del mezzogiorno.
Mi potevo intrattenere un quarto d’ora con lui, in quel momento
non potevo vedere mia mamma, che incontravo poi verso le tre, le
quattro del pomeriggio. Soprattutto i primi tempi, quando riuscivo
a farmi portare nella loro camera, pur di non dover ripartire mi
facevo venire dei terribili mal di pancia. La mia giornata di bambino
era soprattutto di divertimento, era comunque una vita che arricchiva
culturalmente. Mi ricordo alla fine della stagione si faceva la
festa per i figli del personale e ci aveva intrattenuto Josephine
Baker, nel parco dell’albergo, dove c’era un teatrino
con Ghignol. La cantante si era esibita e aveva offerto ad ognuno
un’enorme scatola di cioccolato delizioso, delle “tablettes”
di cioccolato. L’ho mangiato per tutta l’estate e quando
sono arrivato a Pragelato per i miei amici era qualcosa di eccezionale.
Quando si partiva a 15, 16 anni si sapeva già a cosa si
andava incontro, normalmente c’era sempre una persona adulta
che lo accompagnava e lo introduceva al lavoro, i genitori affidavano
i ragazzi a persone conosciute, tant’è che c’erano
degli alberghi con l’80% del personale costituito da pragelatesi.
Mia mamma (francese) immaginava Pragelato una città di 40.000
abitanti, tutti gli italiani che conosceva nell’albergo erano
di Pragelato….
I pragelatesi non si distinguevano dagli abitanti del posto, la
lingua era acquisita e il livello culturale era in media più
alto di quello dei francesi. In Francia si ricostituiva una comunità,
il direttore di ristorante, quello di sala si portavano tutto il
loro personale, così pure il portiere ... Se avevi ambizioni
di carriera transitavi da un albergo ad un altro a seconda di cosa
ti conveniva: una persona di Villardamond è diventata direttore
dell’albergo dove era alloggiata Diana d’Inghilterra
quando è morta.
Il Grand Hotel di Vittel, dove lavoravano mio papà e mia
mamma, era di 150/200 posti letto ed erano 300 dipendenti. Il solo
parco era di una quindicina di ettari e aveva 24 ore su 24 un’orchestra
che suonava un sottofondo musicale. La clientela arrivava con macchine
private o con vagoni letto e con tre o quattro, cinque, sei bauli
e prendevano una suite, quindi era un modo diverso l’utilizzo
dell’albergo, non paragonabile a oggi. I clienti spesso sceglievano
l’albergo nel quale sapevano di ritrovare il maitre, la governante,
quel determinato personale. Era una clientela danarosa. Mia mamma
è stata governante, quindi si occupava delle camere, e cambiava
divisa tre volte al giorno.
Non si vedevano donne in sala ristorante, i ruoli maschili e femminili
erano netti. La donna aveva ruoli più personali come la ristiratura
delle crinoline, la pulizia della suite o della camera che veniva
anche arredata in funzione del tipo di clientela che aveva, la clientela
poteva chiedere anche un arredamento particolare.
Non vi erano contributi previdenziali o assistenziali, non vi era
una paga, veniva dato l’alloggio gratuito e il vitto gratuito
e le mance costituivano lo stipendio e venivano ripartite in funzione
dei compiti svolti. […]
Veniva attribuita una percentuale in funzione alla mansione svolta.
Le ore di lavoro erano di 15, 16 al giorno, ma era una cosa comune,
d’altra parte chi rimaneva in Valle e lavorava la campagna
aveva un orario altrettanto duro: si diceva che erano 8 mesi d’inverno
e 4 d’inferno.
Comunque trovavano del tempo libero da passare in divertimenti fuori
dall’albergo, fosse anche all’una di notte. Ci si trovava
pragelatesi con pragelatesi o addirittura si formavano gruppi nuovi.
Il divertimento principale era il ballo, ma si organizzavano anche
delle feste dove si imitava il cliente che si serviva a tavola.
|
|
| |
|
|
| |
Succedevano spesso delle eccentricità: un
bagno nel latte, si faceva partire un battello per andare a prendere
una forma di gruviera e poi lo si serviva a tavola al cliente che
magari se ne tagliava una fettina sola e tutto il resto veniva regalato
al personale. Ciò non lo si considerava come uno sciupio,
era una cosa normale. Mi ricordo che mia mamma aveva un guardaroba
da non credere, nel 1942-‘43 mia mamma andava a messa sempre
col suo cappellino e ne aveva un quantitativo industriale, perché
c’erano clienti che mettevano i cappellini una volta sola
e poi lo regalavano. Poteva tornare da una stagione con una cappelliera
di 20 o 30 modelli.
All’interno dell’albergo c’erano un’infinità
di mansioni: c’era il servizio di amministrazione, la portineria,
il ristorante e il servizio dei piani, il servizio di trasporto
del cliente dalla stazione …Qualcuno partiva con la sua macchina
e faceva il servizio di taxi in Francia, servizio che dopo la guerra
hanno continuato a fare qui per Sestrieres. Si aspettavano i clienti
a Oulx e si portavano negli alberghi…Principi di Piemonte,
Duche’ ecc…..
Siamo poi ritornati in Italia alla fine di agosto del 1939, siamo
venuti via prima perché c’era stata la dichiarazione
di guerra tra Francia e Germania e Vittel era in Alsazia, dove c’
era la linea Maginot. Il direttore dell’albergo aveva consigliato
mio papà di rientrare: “Non ci sarà la guerra
tra i nostri due paesi, ma è opportuno che tu rientri”.
L’anno successivo mio papà avrebbe dovuto prendere
la direzione dell’albergo, ma purtroppo la guerra era scoppiata
anche tra Italia e Francia e non siamo più tornati. Siamo
rientrati con il sig. Marauda di Luserna San Giovanni che aveva
una Augusta, quelle macchine che avevano l’aquila davanti
sul cofano e faceva il servizio di autista a Vittel.
Io ho trovato più difficile il rientro in Italia che la mia
esperienza di emigrante. Nella scuola fascista ero indicato a dito,
perché avevo la mamma francese e per lungo tempo non ho vestito
la divisa di figlio della lupa.
Coloro che non sono rimpatriati hanno poi ottenuto a fine guerra
la naturalizzazione e la cittadinanza francese.
L’emigrante quando rientrava si sentiva in dovere di raccontare,
di dire quello che aveva vissuto, quello che aveva passato. Ritrovava
le sue tradizioni, arrivava con del denaro e molte esperienze di
vita.
A settembre si partiva col cavallo e si portavano giù a Pinerolo
tre o quattro quintali di patate, un po’ di segale e così
via, ma soprattutto con i soldi guadagnati si acquistavano vino,
mele, pere, castagne, farina , si stava bene.
In pratica fino agli anni 1946 – 47 Pragelato ha continuato
a vivere come aveva vissuto nel 1840 –’50.
Tutte le persone emigranti avevano una “carte de travail”,
era un documento che ti consentiva di lavorare. Alla frontiera bastava
il passaporto, ma senza la carta di lavoro non potevi svolgere un’attività
riconosciuta, legale. E questa carta non è più stata
rinnovata nel dopoguerra e quindi il flusso migratorio è
cessato e le persone che avevano avuto queste esperienze di lavoro
in albergo hanno proseguito la loro attività in alberghi
italiani, come a Venezia, San Remo, Sain Vincent, Torino. Dal 1940
al 1960 tutti gli alberghi di Torino avevano personale di Pragelato.
Mio padre è poi andato a lavorare a Recoaro Terme ed ha avviato
al lavoro una decina di giovani pragelatesi, ma il livello dell’albergo
non lo soddisfaceva, gli avevano dato personale femminile per il
ristorante e lui non lo tollerava e poi diceva che non era abituato
a servire pastasciutte. Anche a livello pensionistico hanno avuto
dei trattamenti di favore, perchè nel frattempo erano stati
fatti degli accordi a livello europeo.
La previdenza sociale in Italia incomincia con il fascismo intorno
agli Anni ’20, mentre in Francia verso il ’30. Lo stato
italiano ha liquidato gli anni lavorativi svolti in Italia e la
Francia quelli svolti sul suo territorio. In Francia non esisteva
la previdenza sociale, ma vi erano casse che gravavano sul datore
di lavoro e garantivano una pensione complementare, bastava esibire
i certificati di lavoro. E i certificati di lavoro tutti li conservavano
perchè erano un po’ il curricolo di ognuno. Alla fine
di ogni stagione ne veniva assegnato uno.
Negli Anni ’30 dei sacerdoti della Valle, come Don Lantelme,
Don Samuel, Don Berger, avevano istituito un’organizzazione,
con sedi a Parigi e a Lione, alla quale potevano rivolgersi le ragazze
e i giovani emigranti, per avere indicazioni, suggerimenti ed aiuti
per qualsiasi evenienza. Era nata soprattutto per le donne, affinché
non si trovassero in una città sconosciuta completamente
abbandonate. Questo per dare un’idea della mentalità
del tempo. |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Bruno Bordiga classe 1930, Porte
(To)
di Ambra Varzani |
|
| |
Il mio trisnonno partiva da Porte per andare a
piedi fino in Francia a lavorare come scalpellino (gli scalpellini
di Porte hanno fatto i portici di via Roma a Torino e il mio trisnonno
era uno di quelli), perché in Italia non c’era abbastanza
lavoro ed aveva 4 figli.
Lui andava a piedi, non era un lavoratore stanziale, ma soltanto
stagionale.
Terminata la stagione tornava a casa con un piccolo stipendio.
Quando i figli sono cresciuti ha lasciato il lavoro dello scalpellino
in Francia ed ha iniziato a fare l’orto e a tenere galline
e conigli. |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Bruno Enrico classe 1932 Pinasca
(To) |
|
| |
“Monterimar”: il paese del torrone (adesso
lì vicino hanno costruito una centrale nucleare ), e’
qui che sono nato e così i miei fratelli. In precedenza i miei
genitori avevano dovuto cambiare due o tre paesi, in un altro luogo
avevano anche comprato una casetta (abitata in precedenza da profughi
della guerra civile di Spagna del ’38)…ma poi da lì,
per mancanza di lavoro, hanno dovuto spostarsi. Poi si stabilirono
a Monterimar dove c’era abbastanza lavoro: mio padre faceva
il muratore, mia madre andava a “fare ore “ al servizio
di varie famiglie.
In Francia ragazzi e ragazze andavano in due scuole dislocate in due
luoghi diversi del paese. Il 14 luglio , festa della Repubblica (presa
della Bastiglia), davano dei dolci e delle patate fritte in un grande
parco dove le truppe coloniali francesi tenevano un concerto.
Nel 1940 quando Germania e Italia hanno occupato la Francia c’è
stata data la possibilità di ritornare in Italia perché
mio padre era perseguitato politico (per motivi politici, finì
anche in carcere nel dicembre del ’43).
Passammo dal Frejus, con il treno; nel mese di dicembre di quell’anno
avevo 8 anni, da poco frequentavo la terza elementare in Francia.
Di quel viaggio di ritorno, ricordo quando il treno si fermò
a Bardonecchia e vidi dei soldati che avevano la penna sul cappello,
erano alpini, avevano le slitte con i cavalli ! Non li avevo mai visti
e ho ancora chiaro questo ricordo…
Quando sono venuto in Italia mi hanno fatto ricominciare dalla prima
classe, sono rimasto indietro di 2 anni. Ho cominciato la scuola con
la classe del ‘34, (io sono del ’32) e mia sorella del
29 ha cominciato con quelli del ‘31.
La mia maestra era di Pragelato , parlava il francese e mi ha aiutato
molto.
Comunque ho imparato subito l’italiano.
Dopo la guerra, quando ormai avevo già 13 ,14 anni non si trovava
lavoro, c’era poco da fare, mio padre lavorava alla R.I.V.
Voleva però tornare in Francia, perchè là si
stava meglio, prima della guerra… dove era stato dal 1925 al
‘40.
Così siamo partiti : eravamo una squadra nella quale c’era
anche gente di Perosa e in questo gruppo c’ero anch’io,
avevo 15 anni nel 1947.
Personalmente non ero molto contento di andare, lasciare i miei amici…sono
partito malcontento…
Avevamo un contratto con un impresario francese per andar a lavorare
là. Se fosse andato tutto bene la mamma e mio fratello ci avrebbero
raggiunto.
In Francia ci andammo a piedi e, anche se bisognava essere in regola
, noi non avevamo i passaporti: non avevamo i documenti , era tutto
clandestino …Passammo da Praly, tutto di nascosto . C’era
un tale chiamato “ Monsignore” che sfruttava quelli che
andavano in Francia: ad uno faceva caricare una fisarmonica, all’altro
una macchina da scrivere , ad un altro ancora del riso (qui in Piemonte
in tempo di guerra c’era il riso, era tesserato ma c’era)
per avere in cambio del sale. Di questo si occupava, “ di questo
tipo di viaggi”.
Il colle d’Abries era stato sempre la strada dei contrabbandieri.
Alcune volte si incontravano dei partigiani che ci prendevano la roba,
in tempo di guerra questi episodi erano frequenti.
La Francia che ritrovammo nel dopoguerra, non era più la Francia
di prima: ora eravamo malvisti; del resto ai Francesi nel ‘40
avevamo dato una pugnalata alla schiena, ma non tutti eravamo colpevoli.
Qui non c’era già più la tessera del pane e il
pane si trovava; là, anche se avevano vinto la guerra, era
ancora tutto tesserato e di non tesserato c’erano solo banane
e cioccolata!
Andavamo ad imbiancare le case degli operai delle ferrovie (lì
c’era un deposito di locomotive).
Abbiamo lavorato da 2-3 padroni, presso un’ impresa di muratori
e imbianchini di proprietà di un signore di […] una brava
persona, che però non ci pagava ci dava solo acconti, ci trattava
da …, insomma, da italiani ed eravamo malvisti .
Nel 1947 c’erano ancora i prigionieri tedeschi di guerra (questi
sì che venivano pagati!), li tenevano per ricostruire gli edifici
danneggiati. A Gap c’era un campo di concentramento, la sera
li riportavano lì.
Stavano sulla parola del padrone, dormivano anche con noi, nelle grange
.
Siamo stati là fino al mese di novembre, ma a novembre avevamo
già mangiato il pane (le scorte) di dicembre .
E cosa fare? (la voce del sig. Enrico è rotta dall’emozione)
Siamo tornati di nuovo in Italia, facendo lavori onesti non era così
facile far fortuna…
Siamo passati dal colle della Croce, dal colle d’Abries non
si poteva passare perché c’era troppa neve. A Praly bisognava
passare tutto di traverso perché c’erano i carabinieri
e la guardia di finanza. Ci dissero: "Fate attenzione sono su!"
Così siamo passati tutto da un’altra parte e siamo andati
a finire al lago Verde, (non c’era ancora il rifugio) per non
farci sorprendere. Abbiamo mangiato solo noci. In un paesino francese,
La Montà, abbiamo chiesto di poter dormire nella stalla ma
non ci volevano ospitare perché la settimana prima, degli italiani
avevano portato via la mucca. Poi mio padre si è fatto riconoscere,
perché si era fermato lì a lavorare quando era andato
in Francia la prima volta. solo per questo ci hanno permesso di restare.
A proposito, quella mucca fu poi recuperata: era finita a Torre Pellice… |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Ester Reynaud classe 1915, San Germano
Chisone (To)
di Tamara Pagetto
|
|
| |
La mamma e il papà della signora Ester, la
mia vicina di casa, sono emigrati in Francia nel 1920 perché
i loro genitori erano troppo poveri per mantenerli. Così in
Francia si sono trovati un’abitazione e si sono sposati.
Il viaggio lo hanno fatto in parte in treno e in parte in carrozza.
Sono rientrati in Italia prima dello scoppio della seconda guerra
mondiale nel 1937 perché i francesi non volevano più
italiani nel loro stato e ci sono rimasti per tutta la vita.
|
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Franco Prinzio classe 1930 Villar
Perosa (To) |
|
| |
Io sono emigrato nel 1947, a fine guerra.
La Francia aveva bisogno di manodopera; io sono venuto a conoscenza
di questo malgrado fossi ancora abbastanza giovane. Io avevo dei parenti
già emigrati in Francia (la loro è una famiglia di Dubbione),
che venivano abbastanza sovente in Italia, anche perché noi,
al termine della guerra, abbiamo avuto subito la possibilità
di mangiare pane bianco e molti altri cibi, anche generi alimentari
che la Francia non aveva ancora. Infatti, subito dopo la mia emigrazione
dall’Italia, ho dovuto munirmi di una tessera per il pane: per
due anni ho avuto un “ticket” (si chiamava così),
e tutti i sabati dovevo recarmi a Place Carnot (a Marsiglia) a prelevare
[…] dove c’era la distribuzione della tessera del pane.
I nostri parenti sapevano che da noi c’era già di tutto,
perché l’Italia aveva accettato l’aiuto dell’America…
In Francia ci prendevano in giro, dicendo: – Voi vi siete venduti
all’America, noi invece andiamo avanti da soli… –
Queste cose mi sono state dette dal momento che mi vantavo di arrivare
da un paese dove non c’era più la tessera del pane e
dove si mangiava grazie agli Americani. Questo ai Francesi dispiaceva
un po’!
Io sono emigrato per un semplice motivo: nostro padre era contadino
e la famiglia aveva del bestiame. A me non piaceva lavorare la terra:
avevo altre attitudini, altre aspirazioni… tra l’altro
avevo sedici o diciassette anni, l’età in cui bisogna
decidere cosa fare. Io purtroppo non avevo alcuna possibilità
di impiego nell’industria o in altri settori, perché
mio padre era proprietario terriero e aveva più di quattro
mucche nella stalla: secondo le regole, per questo motivo, io non
avevo possibilità di essere assunto, né alla RIV, né
al cotonificio, né da nessun’altra parte. Avrei dovuto
lavorare con i miei…
I parenti di Dubbione di cui le ho parlato prima, venendo dalla Francia
hanno potuto dirci che c’era possibilità di emigrare
per trovare impiego e sistemazione.
Quando ho ricevuto la proposta avevo sedici o diciassette anni, anzi,
mi pare diciassette anni, perché mi sembra fosse quella l’età
per avere diritto alla “cart du travaille”, un documento…
e così abbiamo deciso.
Prima ci voleva una richiesta dai parenti della Francia, che scrivevano
alla Prefettura di Torino dicendo che avevano la possibilità
di dar lavoro e che avrebbero garantito vitto, alloggio…
Poi bisognava essere anche in buone relazioni con il maresciallo dei
Carabinieri perché era lui che doveva fare l’indagine
e poi rispondere alla Prefettura. Tutto è andato abbastanza
bene, diciamo benissimo: avevo passaporto e tutto.
Sono riuscito ad avere un permesso di soggiorno per trenta giorni:
sono emigrato con l’intento di fermarmi in Francia e trovare
un lavoro, e questo non era difficile.
Io sono espatriato regolarmente, ma i miei amici di Pinasca e di Dubbione
sono tutti emigrati clandestinamente passando da Sestriere, Cesana,
Clavriere… Lì c’era un viottolo, che andava al
Monginevro: di lì si scendeva a Briançon, si prendeva
il treno e si andava chi a Nimes, chi ad Aix-en-Provence, chi a Marsiglia,
chi sulla Costa Azzurra… e poi si trovava lavoro.
Pinasca era proprio una zona da cui sono partiti molti emigranti....
Gli emigranti di cui io sono a conoscenza erano soprattutto di Pinasca,
ma ce n’era anche qualcuno di San Germano, perché nella
zona di Marsiglia ci sono anche molti valdesi. Io ho conosciuto dei
valdesi, e anche le loro tradizioni: per esempio, il diciassette febbraio,
invece di accendere i falò, in tutte le case dove c’erano
dei valdesi c’era un lumicino sulla finestra. |
|
| |
|
|
| |
Non era facile avere il permesso di soggiorno. C’erano
anche dei costi per avere questi documenti e molta gente, visto che
dalle nostre parti non si stava troppo bene, sceglieva l’emigrazione
clandestina, che costava molto meno e che dava comunque la stessa
garanzia che ha dato a me.
Chi era clandestino veniva impiegato maggiormente in campagna, nei
boschi.
Chi invece aveva intenzione di orientarsi sull’industria doveva
fornirsi di un permesso di soggiorno, perché senza quel documento
non veniva rilasciata la “cart du travaille”.
Io, ad esempio, lavoravo in una fabbrica e dovevo avere tutte le assicurazioni,
i documenti.
A me è successo di farmi male anche facendo il mio lavoro.
L’azienda era collegata con un medico nella stessa zona dove
esisteva l’azienda. Per qualsiasi cosa, ti facevano un permesso
e ti facevano uscire per andarvi. Una volta mi sono piantato un chiodo
in un piede, lì c’era il pericolo del tetano. Difatti
mi hanno fatto uscire subito, mi hanno accompagnato, il medico mi
ha fatto un’iniezione di richiamo… nessun problema.
Il viaggio l’ho fatto accompagnato da mio padre, con partenza
da Villar Perosa: dovevo prendere il treno verso le quattro e mezzo.
Sono salito sul treno a Pinerolo, sono stato accompagnato col cavallo
da mio padre e puntuali siamo arrivati a Pinerolo, dove mi sono imbarcato.
Ho avuto qualche difficoltà lungo il viaggio: in Italia no,
ma in Francia ho rischiato di perdere il treno, perché ho visto
una fontana in una stazione, probabilmente in quella di Nizza; qualcuno
mi aveva detto che avevo il tempo di scendere, andare a bere e tornare:
invece quando sono arrivato vicino alla fontana il treno si è
messo in moto. Sono riuscito ad agganciarmi alla porta … ho
rischiato molto. Comunque sono giunto alla stazione di Marsiglia,
la Saint Charles, poi, siccome mi avevano dato un percorso da seguire,
sapevo di dover scendere a Place Carnot, dove dovevo prendere un tram
che andava poi dove c’erano questi parenti che mi aspettavano.
È andato tutto liscio.
Dopo c’è stato il problema del lavoro. I miei parenti
sono grossi commercianti di grano, paglia e prodotti per il bestiame,
ma in quel periodo in Francia non c’era bisogno di operai nel
commercio, serviva manodopera nelle miniere, nell’edilizia e
nell’industria. Non ho potuto avere il contratto di lavoro,
ma, dopo la scadenza del permesso di soggiorno, bisognava averne uno
o si era obbligati a tornare in Italia. Io non volevo farlo. Tramite
i parenti siamo riusciti a trovare un lavoro nell’industria
edilizia, una fabbrica dove si producevano tegole, abbiamo avuto la
fortuna di trovare una fornace il cui proprietario era emigrato da
Asti. Quest’uomo aveva messo su una grossa azienda, “le
Tuileries de Marseille”, e sapendo che venivo dal Piemonte non
mi è stato difficile ottenere un contratto di lavoro per la
durata di tre anni.
Non ho avuto grosse difficoltà di inserimento, il primo impatto
è stato bellissimo. Ho trovato sempre persone gentili che parlavano
italiano, perché Marsiglia è una città cosmopolita,
e di italiani ce ne sono molti. Allora tutti mi volevano dare una
mano…! In quel periodo molti marsigliesi, magari provenienti
dal Piemonte, parlavano in “provençal”. Il “provençal”
è una lingua che assomiglia molto al piemontese. |
|
| |
|
|
| |
E poi in quel periodo c’era una legge che diceva
che chi non aveva ancora raggiunto i diciotto anni, ma aveva un contratto
di lavoro, doveva per forza frequentare un corso di formazione (mi
sembra di tre giorni alla settimana). A me ha fatto molto piacere:
essendo nell’industria mi hanno proposto da subito di inserirmi
in un corso di disegno industriale, dove non c’era tanto bisogno
di scrivere, quanto di disegnare. Infatti il professore sapeva che,
essendo arrivato da poco, non avevo molta dimestichezza con la lingua.
Mi dava un bullone e mi diceva di farne dei rilievi. Fin lì
io sono sempre stato obbligato a frequentare il corso, per vari motivi,
che riguardavano anche il contratto di lavoro… Quando è
scaduto dopo tre anni, nel cinquanta, avrei anche avuto la possibilità
di restare, però cominciavo a rendermi conto di aver lasciato
la mia casa, i miei terreni, la mia famiglia, ero diventato più
responsabile. Sapevo che i miei avevano molto lavoro in campagna,
mentre io ero là, tutto sommato abbastanza tranquillo. Queste
cose mi hanno fatto decidere di ritornare.
Lo stipendio non era molto buono, ero giovane e lo spendevo quasi
tutto, perché i miei non avevano necessità: io ero emigrato
solo per cambiare vita, per inserirmi, per conoscere… Questo
mi ha anche portato vantaggi successivamente. […]
Negli anni in cui ho vissuto in Francia ho vissuto con una zia vedova
che si occupava di me come fossi stato suo figlio, aveva solo una
grossa paura: sapeva che io ero solo ed arrivavo da un piccolo paese
del Piemonte; trovandomi in una grande città, Marsiglia, avrei
potuto trovare cattive compagnie. Già in quel periodo c’erano
delle persone poco affidabili.
Là mi sono fatto tanti amici e ho conosciuto anche tante famiglie…
In particolare un ragazzo, al quale ho poi fatto conoscere il mio
paese e la mia famiglia.
Non ho mai sofferto di nostalgia. Scrivevo abbastanza sovente ai miei,
ed ero felice. Mi sono trovato in un bel posto. Ho potuto da subito
comprarmi una bicicletta; frequentavo l’Oratorio, perché
i miei parenti erano molto religiosi. La prima cosa che mi hanno detto
è stata: – Qui, la domenica si va a messa e poi all’Oratorio.
– Era quasi un obbligo, ma lo facevo volentieri, perché
sapevo di far contenti i miei parenti . La religione a Marsiglia era
un po’ trascurata, noi abbiamo esportato lì la religiosità,
l’attaccamento alla Chiesa. Non eravamo fanatici, però
noi alla domenica, come si usava fare qua, continuavamo ad andare
a Messa.
Per il resto ero in piena libertà… Ho passato tre anni
molto belli, anche se non ho portato a casa soldi. Mio padre mi diceva:
– Non ti preoccupare, spendi pure soldi… –
Gli italiani a Marsiglia costituivano un gruppo, i piemontesi erano
quelli inferiori come numero, però c’erano moltissime
famiglie emigrate dal sud, ed io ne ho conosciute un’infinità.
Sono stato invitato a mangiare, anche perché la gente emigrata
da tempo voleva sapere dell’Italia recente… Probabilmente
erano persone emigrate negli Anni Venti, non mi ricordo più…
I piemontesi occupavano sempre un posto migliore rispetto agli altri
emigranti, erano un po’ “privilegiati”. Comunque
certi lavori devono pur venir svolti da qualcuno. Per esempio, appena
arrivato dalla zia a Marsiglia, sono stato condotto a vedere la casa,
e poi mia zia mi ha detto: – Guarda, Franco, devi sapere che
qui non c’è il gabinetto. – Ed io: – Ma come
facciamo? Ma dove andiamo?! – Allora mi hanno detto: –
Nel "petite cadanot" c’è un secchio grosso.
Si va lì. – E questo mi ha procurato qualche problema!
Poi ha funzionato, ovviamente. Io ho pensato: “Ma devo poi portarla
via, questa roba?”. Non dovevo: tutte le mattine passava un
signore, un emigrante, con una specie di carro con una cosa simile
ad una botte in metallo, passava a raccogliere tutto. E questo avveniva
nella “Banliue” di Marsiglia, la periferia insomma, perché
nella città c’erano tutti i servizi tranne quello delle
fognature! |
|
| |
|
|
| |
La gente che faceva questo tipo di lavori arrivava
dall’Abruzzo o dal Sud. Molti erano i siciliani, molti i napoletani…
Una regione che invece si distingueva era quella dei toscani. Erano
anche facilitati nella lingua, perché i toscani conoscono perfettamente
l’italiano, e chi conosce bene l’italiano non ha difficoltà
nell’apprendere il francese. Per me è stato difficile,
l’apprendimento della lingua, perché a quei tempi in
Piemonte si parlava solo il dialetto locale ed io quindi conoscevo
in modo molto approssimativo e poco corretto l’italiano.
Le prese in giro sono durate molto poco anche nella fornace dove lavoravo.
Sì, ogni tanto: – Ehi, macarony! – mi sentivo dire,
ma erano cose cui non davo peso. Inoltre, acquisita la lingua, non
c’era più differenza. Io andavo a ballare, ho avuto fidanzate,
andavo ad imparare a nuotare…
Il cibo era molto gustoso e molto vario. La cosa che mi ha colpito
è stata l’abbondanza di carne. Noi a Villar, in quel
periodo, e anche dopo, mangiavamo la carne due o tre volte all’anno.
I polli più belli mia madre li vendeva, si mangiava sempre
qualche gallina che “non guardava bello”.
Mia zia quando mi ha visto mi ha detto: – Ma tu hai bisogno
di cambiare nutrimento. – Io ho risposto: – Eh sì,
ma sai benissimo com’è da noi. –
Lavoravamo tutti e due nella stessa azienda, io e mia zia, avevamo
un intervallo di un’ora e mezza per mangiare. La sua casa non
era lontana dall’azienda, dalla “Tuileries”, così
si poteva passare dal macellaio per prendere le bistecche! Due bisteccone,
ce le facevamo cuocere così… In Francia ho cambiato aspetto
in pochi mesi perché, se per noi la carne era una cosa cara
che non si poteva avere spesso, per i francesi era una cosa normale.
In Francia sono venuto a conoscenza del fatto di andare in ferie.
A Villar non se ne parlava neanche, ma lì i miei parenti avevano
una tenda, quindi si andava sempre in campeggio. Per me questa è
stata una cosa particolare: pensare di dormire sotto una tenda, con
tutta l’attrezzatura; questo mi ha colpito molto. Non riuscivo
neanche a dormire lì sotto... E poi la macchina, un’altra
cosa, il camion, per me era tutto…
Facevo due lavori nella stessa giornata. Lavoravo dalle otto a mezzogiorno
e dall’una e mezza alle cinque, poi si usciva. Dopo partivo
dall’officina e andavo nel magazzino dei miei parenti commercianti
che, specialmente nel periodo primaverile, salivano quasi tutti i
giorni oltre Aix-en-Provence. Si andava nella zona dove producevano
le patate, perché ce n’era una per le patate, una per
i meloni e così via. Mio cugino doveva fare tutti i giorni
un carico di patate: erano sacchi di cinquanta chili, erano preparati
da manodopera spagnola. Gli spagnoli venivano in Francia a fare gli
stagionali. Si ritornava verso le nove. E questo lo facevo così,
per dare una mano e poi mi piaceva conoscere il funzionamento del
camion… Ho avuto la fortuna di avere un datore di lavoro
che mi apprezzava, e dei parenti che mi hanno sempre rispettato,
ma a una condizione: di mantenere buona condotta.
Sono riuscito a ritornare con la loro stima e tutt’ora mantengo
dei buoni rapporti con tutti i parenti.
Anche mio padre mi raccomandava di avere, se possibile, un buon
comportamento nei riguardi della famiglia che mi aveva adottato…
Per esempio, in una zona non molto lontana da quella dei miei parenti,
che si chiama “La Juliette”, arrivavano i carichi dall’Italia
di arance, sapevo che ogni tanto delle persone, di notte, andavano
ed aprivano i vagoni dove erano contenuti i frutti, anche solo per
veder cadere giù le arance ed io ho sempre cercato di restarne
alla larga.
Se avessi sbagliato, sarei finito dai gendarmi, e siccome “i
documenti parlano chiaro”, sarei stato rimpatriato sicuramente…
C’era anche un problema sindacale: in un lavoro industriale,
ci sono gli scioperi e tutto il resto. Tra noi c’erano sette
o otto spagnoli, ma di italiano c’ero solo io. Poi c’erano
anche dei prigionieri tedeschi che alla fine della guerra non sono
tornati in Germania, ma sono rimasti in Francia. A volte succedeva
che il sindacato dell’industria proclamava degli scioperi,
perché alcuni erano scontenti o che. E mia zia mi diceva:
– C’è la “greve”, oggi, ma bisogna
che tu vada, perché sei italiano. Devo dire che i sindacati,
gli stessi delegati, ci dicevano: – C’è la “greve”,
ma vuoi andare a lavorare? Allora vai! – perché sapevano
che non andando avremmo rischiato molto di più. Potevamo
anche farlo, non era detto che succedesse qualcosa di spiacevole;
avremmo potuto rischiare qualcosa… Insomma, era bello da parte
loro, che capivano… |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Irma Giovenale classe 1927 Perosa
Argentina (To) |
|
| |
Mi ricordo che i miei si sono sposati verso il 1920
e poi sono emigrati in Francia.
Qui facevano gli agricoltori, perché avevano qualche pecora,
qualche mucca, alla moda di una volta, mio papà faceva il taglialegna;
poi si sono sposati e sono andati, tramite mio papà che aveva
un fratello in Francia, nelle Hautes Alpes, in una famiglia. Mia mamma
faceva i lavori di casa, mio papà invece andava a “sbattere
le mandorle”, faceva “le stagioni”. Poi si è
trovato un lavoro in un cava di pietre e faceva lo scalpellino, faceva
il manovale perché non era specializzato. Dopo un anno così,
si è fatto male: una pietra gli ha schiacciato un piede. E’
stato un po’ in ospedale e poi hanno deciso di tornare, perché
mia mamma nel frattempo aspettava un figlio, e forse ero io: non so!
Poi sono tornati in Italia e sono rimasti sempre qua.
Mio papà veramente era nato in Francia, ma era venuto via subito,
piccolo, piccolo, perché sua mamma “bailava". Sua
mamma si è fermata in Francia perché dava il suo latte
ai figli dei ricchi, invece mio papà è stato allevato
qua in Italia, come han potuto, con il latte di mucca.
La mamma poi è morta che aveva ventitrè anni. Suo papà
si è risposato ed ha avuto cinque figli e cinque figlie. |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Nellina Sappè classe 1935
San Germano Chisone (To)
di Martina Bouchard
|
|
| |
Sappe’ Adolfo e Long Luigia, i genitori di mia
nonna Nellina, sono emigrati insieme, intorno al 1920.
Sono emigrati perché c’era stata la guerra e quindi non
trovavano più lavoro.
In Francia, Sappe’ Adolfo e Long Luigia, di mestiere, facevano
i camerieri, si sono trovati bene.
Si sono spostati in treno: da Pinerolo fino in Francia, a Cannes.
Ma nel 1930 sono tornati a San Germano, dove erano riusciti ad acquistare
una casa nella borgata Colombatti. Appena sono tornati è nata
Denise, la nonna di Corinne; quattro anni dopo, nel 1935, è
nata mia nonna Nellina.
|
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Ughetto Malvina classe 1919 Pinasca
(To) |
|
| |
La famiglia di mio padre era composta da tre sorelle
(Marietta madre di Ines Ghigo, Serafina madre della madrina di mia
mamma Virginia Pelagio, Lessina Pelagio e di un’altra chiamata
"Sole dell’Autassa" perché era molto bella
(mamma di Ermelinda Beccari); una terza sorella abitava a Giborgo.
Aveva anche un fratello Gaudenzio Ughetto padre di Linda e Cesare
che emigrerà in Francia più tardi e farà ritorno
più o meno negli anni ’20.
Quando io ero piccola Marietta e Serafina si erano già spostate
in Francia con le figlie che sposarono dei fratelli Pelagio.
La famiglia di Serafina commerciava nel legname e dava lavoro ad altri
che arrivavano da Grandubbione.
Alcuni facevano le stagioni, altri si fermavano per anni, come mio
padre, e inviavano alla famiglia rimasta in Italia i soldi.
La vita qui era molto dura e mia madre si era fatta dei debiti con
tutti i parenti, i primi soldi che ricevette da mio padre li usò
per pagare proprio queste persone, che tra l’altro non la volevano
più aiutare. Prima di andare in Francia mio padre era stato
malato e la mia famiglia si era indebitata; l’aveva poi guarito
il prete di Talucco con erbe e spugnature di acqua fredda.
In Francia è stato accolto dalla famiglia di mia madrina e
si è fermato parecchi anni. Non mi ricordo se tornava tutti
gli anni, ma non credo perchè allora si spostavano tutto a
piedi e il viaggio era lunghissimo. Mi ricordo che la prima volta
che l’ho visto ho chiesto a mia madre chi fosse e mi nascondevo
dietro le sue gonne. Ci portava un po’ di cioccolato, noi eravamo
molto golose. Qui la vita era molto dura, ogni volta che lui tornava
la metteva incinta, poi lei da sola doveva tirare avanti la famiglia,
il lavoro nei campi, occuparsi degli animali. Quando io avevo 14 anni
lui non era ancora tornato. E’ arrivato un po’ prima del
mio matrimonio ( Natale 1939), mia madrina non voleva ancora che rientrasse,
ma lui desiderava venire a morire a casa sua e purtroppo fu ucciso
dai "repubblichini" pochi anni dopo (1945).
Mia madrina Virginia Pelagio prima di partire per la Francia lavorava
come impiegata alla RIV, ma la sua famiglia decise di trasferirsi
tutta in Francia e lei fu costretta ad abbandonare il suo lavoro,
ma lo rimpianse sempre. In Francia si fermarono nelle Basses Alpes
e commerciavano legname. Lei sapeva cubare il legno, teneva la contabilità,
anche quella dei vicini. |
|
| |
|
|
| |
INTERVISTA a Marta Valletti classe 1936 Perrero
(To) |
|
| |
Sono emigrata in Francia nel 1938 a gennaio. Mio padre
si chiamava Albino e mia madre Eleonora.
Mio padre non aveva più lavoro, allora era partito alla ricerca
di un’occupazione in Francia, aveva lasciato a Perrero sua moglie
con sette bambini.
Commerciava nel legname e faceva il carbone e mia madre aveva un negozio
di alimentari.
Mio padre non trovava più lavoro per una questione politica,
infatti si era rifiutato di prendere la tessera del partito fascista
perché non ne condivideva le idee, così si è
trovato disoccupato, praticamente è stato obbligato a partire
per sfamare la sua numerosa famiglia.
I fascisti avevano anche chiesto alle donne di donare al partito il
proprio anello di matrimonio e tutto l’oro che possedevano:
mia madre non aveva voluto. Erano momenti molto difficili.
Dunque mio padre è partito, ha cercato lavoro, ha affittato
una cascina e, siccome non avevano denaro, lui ha lavorato in un’altra
fattoria che gli prestava il cavallo e gli attrezzi per poter mandare
avanti quella che avevano in affitto.
Quindi faceva due lavori contemporaneamente e in cambio del suo lavoro
gli davano patate, legumi, frutti della terra, così è
riuscito a racimolare un po’ di denaro che gli ha permesso di
riunire la famiglia in Francia.
Mia madre intanto continuava ad avere il suo negozio e poi l’ha
venduto ad un certo signor Costabello di Perrero.
Nel 1938 mio padre è venuto a prenderci, aveva affittato un
pulmino con il conducente; abbiamo portato via solo l’indispensabile:
i documenti, il vestiario, un po’ di vasellame e di pentolame.
I mobili invece li abbiamo lasciati tutti qui. Io ero piccolissima,
sono nata nel dicembre del 1936 e siamo partiti a gennaio del 1938,
quindi avevo appena un anno, perciò non ricordo nulla del viaggio.
Quando sono successi questi avvenimenti mio padre aveva 44 anni e
quindi aveva un certo senso di responsabilità. Non è
come quando si parte a 20 anni […]
Si sono recati a Manosque e la fattoria si trovava in un piccolo villaggio
vicino che si chiama Pierrevert, si trova nelle Basses Alpes. Siamo
rimasti a Carnine 4 anni e i miei genitori hanno avuto ancora un bambino
(eravamo a quota 8 figli). Si sono poi trasferiti in una cascina più
grande alla Bastide des Jourdan nel Vaucluse.
Le sorelle e i fratelli dei miei genitori erano già in Francia
salvo uno o due, un fratello era addirittura emigrato in America.
Così ora noi in Italia non abbiamo più nessuno, solo
cugini.
In Italia era un periodo molto duro, non c’era lavoro, mentre
in Francia mancava la manodopera e si trovava facilmente un’occupazione.
La mia famiglia si è trovata bene in Francia, mio padre ha
imparato a scrivere il francese e lo parlava benissimo, senza accento
italiano; parlava anche il “patuà” del posto, il
provenzale, che assomiglia molto al piemontese. Tuttavia i primi tempi
sono stati un po’ difficili: ci dicevano: - Venite a mangiare
il nostro pane!- - Les transalpin qui viennent manger notre pain -…
Dopo è cambiato perché all’emigrazione italiana
sono succedute quella spagnola, portoghese e adesso algerina e dall’Est
europeo. Comunque per gli italiani è stato più facile
inserirsi perché arrivavano da paesi che avevano la stessa
religione dei francesi e una cultura e modi di vita simili, anche
la lingua tutto sommato non era un ostacolo molto grande. […]
A sei anni sono andata a scuola, non sapevo parlare il francese, in
casa parlavamo solo piemontese, il francese lo usavamo solo con i
francesi. Ero tutta timida e a disagio perché non capivo e
non sapevo rispondere. Noi italiani ci chiamavano “babì“,
“macaronì”. Nel periodo in cui è emigrato
mio padre non eravamo ben visti, mi ricordo che mi canzonavano “la
babì, la babì”… |
|
| |
|
|
| |
Mio papà soffriva di nostalgia, mia mamma no:
mia madre ha lasciato qui sua madre e non è mai più
tornata a trovarla, mio padre invece tornava tutti gli anni a Perrero.
A casa di mia nonna ho trovato le lettere che mia madre scriveva alla
sua in cui diceva che era molto felice in Francia, avevano avuto un
buon raccolto, mettevano da parte molti soldi …ma non era vero
niente; non si erano arricchiti, semplicemente vivevano meglio. Mia
nonna è morta nel 1948, io non l’ho conosciuta.
Mio padre tornava qui in inverno, perché in estate aveva troppo
lavoro, ma non si sentiva più italiano, si era fatto naturalizzare
francese. Un inverno cadde ammalato e diceva: -Non voglio morire qui,
voglio tornare in Francia-.
Io sono tornata in Italia nel 1954, avevo 18 anni e sono andata a
casa della nonna materna. Anche mio padre aveva una casa a Perrero,
ma l’abbiamo venduta nel 1954 e abbiamo acquistato la cascina
a Cadenet, nel 1956. Dopo l’acquisto della cascina mio papà
non faceva più il boscaiolo: avevamo molta terra da coltivare,
21 ettari di vigne, avevamo delle pecore […]
Due fratelli lavoravano nella cascina, i più grandi, avevano
una bella casa a Pierrevert.
Mia madre è morta nel 1956, aveva 55 anni, era molto giovane
e tutte le mie sorelle erano già sposate, io no. Sono rimasta
sola con mio padre e i miei tre fratelli, lavoravo alla conduzione
della cascina e di lavoro ce n’era molto. Allevavamo molti animali:
maiali, piccioni, oche, faraone, tacchini, mucche, capre, cavalli…
Di questo si occupava mia madre e dopo è toccato a me.
Vendevamo la carne di questi animali per guadagnare soldi. Non compravamo
nulla da mangiare; andavamo alla macelleria solo la domenica per comprare
il “pot-au-feu”; mangiavamo il merluzzo il venerdì
perché mio padre era molto religioso, andava a messa per Natale
e Pasqua, mia madre no. Per tutto il resto della settimana consumavamo
prodotti della fattoria: uccidevamo il maiale, facevamo salami, salsicce,
prosciutti… Con i prodotti dell’orto si facevano conserve
per l’inverno, raccoglievamo noci, noccioline […]
Avevamo il trattore, il camion, avevamo tutti i macchinari che servivano
per lavorare la terra, in particolare il grano e la vigna.
A Perrero la madre di mia mamma è rimasta sola con il figlio
che è morto poi prima di lei e così una mia zia che
abitava in Francia è venuta ad accudire mia nonna quando è
diventata anziana, perché in Italia non aveva più parenti.
Quando mio padre è morto nel 1964 abbiamo venduto la fattoria
e l’abbiamo divisa in nove parti. Mio fratello, che non era
sposato e aveva sempre lavorato con mio padre, ha avuto la casa con
le terre e noi il resto […]. In seguito è stata acquistata
dal signor Dubrune che è un grande produttore agricolo e ha
trasformato la proprietà in un vigneto. Ora lì si produce
un vino famoso chiamato “La Cavale”: c’è
un cavallo sull’etichetta.
Nella zona dove eravamo emigrati noi c’erano molti italiani,
sono rimaste poche le persone veramente francesi. Nei dintorni di
Marsiglia, ad esempio, ci sono moltissimi italiani, ci sono più
cognomi italiani che francesi. In quella zona andavano soprattutto
per fare i muratori.
Io mi sono sposata con un vero francese, la sua famiglia risale al
1700 […] mio figlio ha fatto delle ricerche, lui non può
più dire di essere un puro francese, ma è orgoglioso
di avere anche sangue italiano […]
La prima volta che sono tornata in Italia, a 18 anni, ho trovato tutto
bello, il paesaggio era diverso, perché noi non abbiamo montagne.
Quando sono arrivata alla casa dove abito attualmente e dove mia madre
è nata, mi sono sentita turbata e mi sono messa a piangere
perché pensavo che mia madre non era più tornata. Ed
è a partire da quel momento che ho amato quella casa, in seguito
l’ho fatta ristrutturare e ci torno tutti gli anni […] |
|
| |
|
|
|