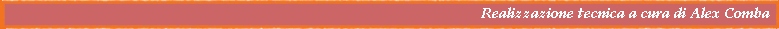|
| |
La zona di Marsiglia era certamente tra
le zone più frequentate, tant’è ...(continua) |
|
 |
| |
“…Mio padre non aveva più lavoro,
allora era partito alla ricerca di un’occupazione in ...(continua)" |
|
 |
| |
“…Durante i due anni di permanenza non
cambiai mai le mie mansioni, ero il ...(continua)" |
|
 |
| |
“…Tramite i miei parenti siamo riusciti
a trovare un lavoro nell’industria edilizia...(continua)" |
|
 |
| |
“…Andavamo ad imbiancare le case degli
operai delle ferrovie...(continua)" |
|
 |
| |
“…L’emigrazione di questo tipo forniva
ad ogni famiglia una notevole entrata...(continua)" |
|
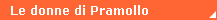 |
| |
“… Giuseppina Reynaud, nata a Pramollo,
nel 1899, è andata a fare la balia in...(continua)" |
|
|
| |
Verso quale futuro |
|
| |
Oltre alla vicinanza con le nostre Valli
e ad antichi legami di tipo economico e politico, la Francia aveva
un grande bisogno di braccia per far funzionare la propria economia:
a differenza dell’Italia, era meno abitata, l’industria
vi si era sviluppata prima, il suo territorio era più pianeggiante,
adatto alle attività agricole.
Le regioni francesi verso cui si dirigevano maggiormente gli emigranti
delle nostre Valli erano le seguenti: Provece, Côte d’Azur,
Rhone Alpes, Lorraine, Centre.
La zona di Marsiglia era certamente tra le
zone più frequentate, tant’è che Marta
Valletti, classe 1936, dice:
“… Nella zona dove eravamo emigrati
noi c’erano molti italiani, sono rimaste poche le persone veramente
francesi. Nei dintorni di Marsiglia, ad esempio, ci sono moltissimi
italiani, ci sono più cognomi italiani che francesi…”
Alex Berton, classe 1933, parla ancora di Marsiglia,
ma allarga il campo:
“… Il flusso dei pragelatesi
si dirigeva su Marsiglia, Cannes, Nizza, ma più massicciamente
sulla Savoia: Chambery, Annecy, Aix- Le- Bain, Evian o Parigi, Dihar,
Vittel...”
|
|
| |
 Parigi
era la meta delle donne che si recavano a servizio presso le famiglie
facoltose in qualitÓ di balie o di dame di compagnia. Parigi
era la meta delle donne che si recavano a servizio presso le famiglie
facoltose in qualitÓ di balie o di dame di compagnia. |
|
| |
|
|
| |
L’estrema povertà o più semplicemente
la prospettiva di guadagni migliori inducevano le persone a scegliere
la via dell’emigrazione. Strada consolidata nel tempo, che nella
prima metà del Novecento veniva spesso preferita al nascente
lavoro in fabbrica.
Anche perché essere assunti nelle fabbriche che erano nate
in Valle non era così facile, ricorda Franco
Prinzio, classe 1930, emigrato nel primo dopoguerra:
“… Io sono emigrato per un
semplice motivo: nostro padre era contadino e la famiglia aveva
del bestiame. A me non piaceva lavorare la terra: avevo altre attitudini,
altre aspirazioni… tra l’altro avevo sedici o diciassette
anni, l’età in cui bisogna decidere cosa fare. Io purtroppo
non avevo alcuna possibilità di impiego nell’industria
o in altri settori, perché mio padre era proprietario terriero
e aveva più di quattro mucche nella stalla: secondo le regole,
per questo motivo, io non avevo possibilità di essere assunto,
né alla RIV, né al cotonificio, né da nessun’altra
parte. Avrei dovuto lavorare con i miei…”
|
|
| |
|
|
| |
Con l’avvento al potere del fascismo
le cose si complicarono ancora: per trovare lavoro era necessaria
la tessera del partito, così molte persone che non volevano
piegarsi a questi ricatti, presero ancora una volta la via dell’emigrazione.
E’ il caso di Albino Valletti,
padre di Marta.
 “…Mio
padre non aveva più lavoro, allora era partito alla ricerca
di un’occupazione in Francia, aveva lasciato a Perrero sua moglie
con sette bambini. “…Mio
padre non aveva più lavoro, allora era partito alla ricerca
di un’occupazione in Francia, aveva lasciato a Perrero sua moglie
con sette bambini.
Mio padre commerciava nel legname e faceva il carbone e mia madre
aveva un negozio di alimentari.
Mio padre non trovava più lavoro per una questione politica,
infatti si era rifiutato di prendere la tessera del partito fascista
perché non ne condivideva le idee, così si è
trovato disoccupato, praticamente è stato obbligato a partire
per sfamare la sua numerosa famiglia…”
|
|
| |
|
|
| |
 Molti
emigranti dalle Valli in Francia si occupavano di legname, facevano
i carbonai, i boscaioli. Quelli che riuscirono a fare fortuna diventarono
proprietari di una piccola impresa commerciale. Molti
emigranti dalle Valli in Francia si occupavano di legname, facevano
i carbonai, i boscaioli. Quelli che riuscirono a fare fortuna diventarono
proprietari di una piccola impresa commerciale. |
|
| |
|
|
| |
Altri trovarono diverse occupazioni sempre in campo
agricolo.
Marta Valletti:
“… Dunque mio padre è
partito, ha cercato lavoro, ha affittato una cascina e, siccome
non avevano denaro, lui ha lavorato in un’altra fattoria che
gli prestava il cavallo e gli attrezzi per poter mandare avanti
quella che avevano in affitto.
Quindi faceva due lavori contemporaneamente. In cambio del suo lavoro
gli davano patate, legumi, frutti della terra, così è
riuscito a racimolare un po’ di denaro che gli ha permesso
di riunire la famiglia in Francia…”
Il padre di Marta Valletti non era il solo a fare due lavori, anche
Franco Prinzio, impiegato
nell’industria edilizia, visse una situazione simile:
 “…Facevo
due lavori nella stessa giornata. Lavoravo dalle otto a mezzogiorno
e dall’una e mezza alle cinque, poi si usciva. Dopo partivo
dall’officina e andavo nel magazzino dei miei parenti commercianti
che, specialmente nel periodo primaverile, salivano quasi tutti
i giorni oltre Aix-en-Provence. Si andava nella zona dove producevano
le patate, perché ce n’era una per le patate, una per
i meloni e così via. Mio cugino doveva fare tutti i giorni
un carico di patate: erano sacchi di cinquanta chili, erano preparati
da manodopera spagnola. Gli spagnoli venivano in Francia a fare
le stagioni. C’era un grosso produttore, e tutti i giorni
dopo le cinque si saliva col camion a caricare queste patate che
lui aveva ordinato. Allora io uscivo dalla fabbrica, salivo sul
camion con lui e andavamo a caricare. Si ritornava verso le nove,
cenavo con loro e poi tornavo da mia zia. E questo lo facevo così,
per dare una mano e poi mi piaceva conoscere il funzionamento del
camion…” “…Facevo
due lavori nella stessa giornata. Lavoravo dalle otto a mezzogiorno
e dall’una e mezza alle cinque, poi si usciva. Dopo partivo
dall’officina e andavo nel magazzino dei miei parenti commercianti
che, specialmente nel periodo primaverile, salivano quasi tutti
i giorni oltre Aix-en-Provence. Si andava nella zona dove producevano
le patate, perché ce n’era una per le patate, una per
i meloni e così via. Mio cugino doveva fare tutti i giorni
un carico di patate: erano sacchi di cinquanta chili, erano preparati
da manodopera spagnola. Gli spagnoli venivano in Francia a fare
le stagioni. C’era un grosso produttore, e tutti i giorni
dopo le cinque si saliva col camion a caricare queste patate che
lui aveva ordinato. Allora io uscivo dalla fabbrica, salivo sul
camion con lui e andavamo a caricare. Si ritornava verso le nove,
cenavo con loro e poi tornavo da mia zia. E questo lo facevo così,
per dare una mano e poi mi piaceva conoscere il funzionamento del
camion…”
|
|
| |
|
|
| |
Aldo Roventi Beccari,
classe 1930, porta la sua testimonianza di lavoratore agricolo:
 “…
Durante i due anni di permanenza non cambiai mai le mie mansioni,
ero il “sartiè” cioè l’addetto ai
cavalli che erano impiegati ad arare, seminare, mietere, trainare
i carri, ecc. “…
Durante i due anni di permanenza non cambiai mai le mie mansioni,
ero il “sartiè” cioè l’addetto ai
cavalli che erano impiegati ad arare, seminare, mietere, trainare
i carri, ecc.
Quindi facevo anche lo stalliere, e al pomeriggio si provava a guidare
il trattore (il primo che abbia mai visto).
Bisogna pensare che era finita da poco la 2° guerra mondiale,
a Dieppe, distante circa 30 km dalla fattoria, erano sbarcati gli
alleati, la Francia stava lentamente tentando di ricominciare a
vivere in un modo normale.
La paga sinceramente non mi sembrava un granchè: per 5000
franchi al mese, compresi vitto e alloggio, dovevo lavorare dalle
cinque del mattino alle dieci di sera di tutti i giorni dell’anno,
tranne una settimana di vacanza.
L’alloggio era fornito dai proprietari ed era una stanza senza
servizi in una specie di magazzino per gli attrezzi, freddo e polveroso.
La cosa che più apprezzavo era poter lavorare gestendomi
autonomamente, ovviamente dovevano esserci i risultati a fine giornata…”
|
|
| |
|
|
| |
Spesso i lavori erano pesanti e poco sicuri.
Manodopera veniva impiegata anche nelle cave e nelle miniere.
Ambra Varzani che ha intervistato il nonno, Bruno
Bordiga (classe 1930), dice: “…
Il mio tris nonno partiva da Porte per andare a piedi fino in Francia
a lavorare come scalpellino…”
Irma Giovenale, classe
1927, di Perosa Argentina, ricorda:
“… I miei si sono sposati
verso il 1920 e poi sono emigrati in Francia […] tramite mio
papà che aveva un fratello là, nelle Hautes Alpes,
in una famiglia. Mia mamma faceva i lavori di casa, mio papà
invece andava a “sbattere le mandorle”, faceva “le
stagioni”. Poi si è trovato un lavoro in un cava di
pietre e faceva lo scalpellino, faceva il manovale perché
non era specializzato. Dopo un anno così, si è fatto
male: una pietra gli ha schiacciato un piede. E’ stato un
po’ in ospedale e poi hanno deciso di tornare perché
mia mamma in quel frattempo aspettava un figlio …”
|
|
| |
|
|
| |
 Soprattutto
nella zona di Marsiglia si dirigeva il flusso di persone che lavoravano
nell’edilizia: molti facevano i muratori, ma alcuni erano impiegati
nelle industrie collegate a questo settore, racconta Franco
Prinzio: Soprattutto
nella zona di Marsiglia si dirigeva il flusso di persone che lavoravano
nell’edilizia: molti facevano i muratori, ma alcuni erano impiegati
nelle industrie collegate a questo settore, racconta Franco
Prinzio:
“…Tramite i miei parenti siamo
riusciti a trovare un lavoro nell’industria edilizia, una fabbrica
dove si producevano tegole, abbiamo avuto la fortuna di trovare una
fornace il cui proprietario era emigrato d'Asti. Quest’uomo
aveva messo su una grossa azienda, “le Tuileries de Marseille”,
e sapendo che venivo dal Piemonte non mi è stato difficile
ottenere un contratto di lavoro per la durata di tre anni…”
In queste situazioni il lavoratore era maggiormente tutelato.
Franco Prinzio:
“… Io, ad esempio, lavoravo
in una fabbrica, e dovevo avere tutte le assicurazioni, i documenti,
ecc., nei lavori di campagna, invece, questo non si richiedeva.
A me è successo di farmi male anche facendo il mio lavoro.
L’azienda era collegata con un medico nella stessa zona dove
esisteva l’azienda. Per qualsiasi cosa, ti facevano un permesso.
Uscivo e andavo dal medico. Era organizzato così…
Una volta mi sono piantato un chiodo in un piede, lì c’era
il pericolo del tetano. Difatti mi hanno fatto uscire subito, mi
hanno accompagnato dal medico che mi ha fatto un’iniezione
di richiamo… nessun problema.
E poi in quel periodo c’era una legge che diceva che chi non
aveva ancora raggiunto i diciotto anni, ma aveva un contratto di
lavoro, doveva per forza frequentare un corso di formazione (mi
sembra di tre giorni alla settimana). A me ha fatto molto piacere:
essendo nell’industria mi hanno proposto da subito di inserirmi
in un corso di disegno industriale, dove non c’era tanto bisogno
di scrivere, quanto di disegnare. Infatti il professore sapeva che,
essendo arrivato da poco, non avevo molta dimestichezza con la lingua.
Mi dava un bullone e mi diceva di farne dei rilievi…”
|
|
| |
|
|
| |
Dalle interviste emergono i legami di solidarietà
che legano gli italiani emigrati nel nuovo paese. Tuttavia la tipologia
di impieghi era molti diversificata e non sempre così rosea.
Franco Prinzio:
“… Gli italiani a Marsiglia
costituivano un gruppo, i piemontesi erano quelli inferiori come
numero, però c’erano moltissime famiglie emigrate dal
Sud, ed io ne ho conosciute un’infinità. Sono stato
invitato a mangiare, anche perché la gente emigrata da tempo
voleva sapere dell’Italia recente… Probabilmente erano
persone emigrate negli Anni Venti, non mi ricordo più…
I piemontesi occupavano sempre un posto migliore rispetto agli altri
emigranti, erano un po’ “privilegiati”. Comunque
certi lavori devono pur venir svolti da qualcuno. Per esempio, appena
arrivato dalla zia a Marsiglia, sono stato condotto a vedere la
casa, e poi mia zia mi ha detto: – Guarda, Franco, devi sapere
che qui non c’è il gabinetto. – Ed io: –
Ma come facciamo? Ma dove andiamo?! – Allora mi hanno detto:
– Nel “petite cadanot”, c’è un secchio
grosso. Si va lì. – E questo mi ha procurato qualche
problema! Poi ha funzionato, ovviamente. Io ho pensato: “Ma
devo poi portarla via io, questa roba?”. Non dovevo: tutte
le mattine passava un signore, un emigrante, con una specie di carro
con una cosa simile ad una botte in metallo, passava a raccogliere
tutto. E questo avveniva nella “Banliue” di Marsiglia,
la periferia insomma. Perché nella città c’erano
tutti i servizi tranne quello delle fognature!
La gente che faceva questo tipo di lavori arrivava dall’Abruzzo
o dal Sud. Molti erano i siciliani, molti i napoletani…”
|
|
| |
|
|
| |
Bruno Enrico
racconta un’altra situazione di lavoro riferita al periodo immediatamente
successivo alla fine della seconda guerra mondiale.
“… Andavamo ad imbiancare
le case degli operai delle ferrovie (lì c’era un deposito
di locomotive).
Abbiamo lavorato da due o tre padroni, presso un’ impresa
di muratori e imbianchini di proprietà di un signore di […]
una brava persona, che però non ci pagava ci dava solo acconti,
ci trattava da …, insomma, da italiani ed eravamo malvisti…”
Dall’alta Valle partiva manodopera che trovava impiego come
barman, venditori di caldarroste, lavoratori nelle “brasserie”,
operai nelle fabbriche di biciclette o nelle coltivazioni di tabacco.
Tantissime persone trovavano lavoro nel settore alberghiero, nelle
grandi città della costa Azzurra, o nella regioni dei laghi
e delle acque minerali.
Pragelato, in particolare, sviluppò una consolidata tradizione
verso questo tipo di emigrazione a carattere stagionale, che per
altro, risultava estremamente redditizia.
|
|
| |
|
|
| |
Alex Berton
afferma:
“… L’emigrazione di
questo tipo forniva ad ogni famiglia una notevole entrata, un guadagno
inimmaginabile per l’epoca, se consideriamo il fatto che allora
la Lira valeva più del Franco francese.
I miei genitori si sono sposati nel 1927, hanno costruito la casa
dove ora vivo io, era già finita nei primi Anni Trenta, pagata
con il solo introito delle mance…”
Gli alberghi verso cui si dirigevano erano lussuosi, richiedevano
moltissimo personale e un lavoratore ne raccomandava un altro, tanto
che alla fine Alex Berton
dice:
“… erano degli alberghi con
l’80% del personale costituito da pragelatesi. Mia mamma (francese)
immaginava Pragelato una città di 40.000 abitanti, tutti
gli italiani che conosceva nell’albergo erano di Pragelato…
 …
Il Grand Hotel di Vittel, dove lavoravano mio papà e mia
mamma, era di 150/200 posti letto e c’erano 300 dipendenti.
Il solo parco era di una quindicina di ettari e aveva 24 ore su
24 un’orchestra che suonava un sottofondo musicale. La clientela
arrivava con macchine private o con vagoni letto e con tre o quattro,
cinque, sei bauli […], sceglievano l’albergo nel quale
sapevano di ritrovare il maitre, la governante, quel determinato
personale. Era una clientela danarosa. Mia mamma è stata
governante, quindi si occupava delle camere e cambiava divisa tre
volte al giorno. …
Il Grand Hotel di Vittel, dove lavoravano mio papà e mia
mamma, era di 150/200 posti letto e c’erano 300 dipendenti.
Il solo parco era di una quindicina di ettari e aveva 24 ore su
24 un’orchestra che suonava un sottofondo musicale. La clientela
arrivava con macchine private o con vagoni letto e con tre o quattro,
cinque, sei bauli […], sceglievano l’albergo nel quale
sapevano di ritrovare il maitre, la governante, quel determinato
personale. Era una clientela danarosa. Mia mamma è stata
governante, quindi si occupava delle camere e cambiava divisa tre
volte al giorno.
Non si vedevano donne in sala ristorante, i ruoli maschili e femminili
erano netti. La donna aveva ruoli più personali come la ristiratura
delle crinoline, la pulizia della suite o della camera che veniva
anche arredata in funzione del tipo di clientela che aveva […]
Non vi erano contributi previdenziali o assistenziali, non vi era
una paga, veniva dato l’alloggio gratuito e il vitto gratuito
e le mance costituivano lo stipendio e venivano ripartite in funzione
dei compiti svolti. […]

Le ore di lavoro erano di 15, 16 al giorno, ma era una cosa comune,
d’altra parte chi rimaneva in Valle e lavorava la campagna
aveva un orario altrettanto duro: si diceva che erano 8 mesi d’inverno
e 4 d’inferno…”
Questo tipo di lavoro consentiva di migliorare la propria situazione
a anche di fare carriera. |
|
| |
|
|
| |
Le donne delle Valli venivano occupate come cameriere,
governanti, dame di compagnia e balie presso famiglie facoltose.
Alda Jahier,
classe 1932, ricorda:
“… Giuseppina
Reynaud, nata a Pramollo, nel 1899, è andata a fare la balia
in Francia.
Aveva lasciato qui a Pramollo il suo primo figlio ed era andata
ad allattare il neonato di una ricca famiglia di Parigi; i soldi
che le davano li spediva alla famiglia.
Per molti anni è rimasta “al servizio” di quella
famiglia, facendo tanti lavori.
Come lei hanno fatto molte donne di Pramollo…”
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Escludendo l’impiego nei grandi alberghi, non
si può dire che gli emigranti in genere godessero di salari
particolarmente alti, soprattutto nel periodo che seguì la
seconda guerra mondiale.
I lavoratori agricoli, in più di una situazione, venivano pagati
con prodotti della terra o con vitto e alloggio. Tuttavia questi magri
introiti dovevano rappresentare un miglioramento rispetto alla condizione
di vita dei propri luoghi d’origine, almeno non si gravava sul
magro bilancio familiare. Ciò che permetteva ai nostri emigranti
di riscattarsi e di compiere un salto di qualità era una grande
forza di volontà nel perseguire un sogno: la cascina di proprietà,
il piccolo esercizio commerciale… e nel moltiplicare, a questo
scopo, le ore di lavoro. Essere emigranti significava essere meno
tutelati sul lavoro per quanto riguardava i propri diritti: in campo
sanitario, come abbiamo già visto, ma anche in campo sindacale.
Franco Prinzio:
“… Era anche un problema
sindacale: in un lavoro industriale, ci sono gli scioperi e tutto
il resto. Tra noi c’erano sette o otto spagnoli, ma di italiano
c’ero solo io. Poi c’erano anche dei prigionieri tedeschi
che alla fine della guerra non sono tornati in Germania, ma sono
rimasti in Francia. A volte succedeva che il sindacato dell’industria
proclamava degli scioperi, perché alcuni erano scontenti
o che. E mia zia mi diceva: – C’è la “greve”,
oggi, ma bisogna che tu vada, perché sei italiano -. Devo
dire che i sindacati, gli stessi delegati, ci dicevano: –
C’è la “greve”, ma vuoi andare a lavorare?
Allora vai! –, perché sapevano che non andando avremmo
rischiato molto di più. Potevamo anche farlo, non era detto
che succedesse qualcosa di spiacevole; avremmo potuto rischiare
qualcosa… Insomma, era bello da parte loro, che capivano…”
Per quanto riguarda la previdenza sociale Alex
Berton afferma:
 “…
In Francia non esisteva la previdenza sociale, ma vi erano casse
che gravavano sul datore di lavoro e garantivano un pensione complementare,
bastava esibire i certificati di lavoro. E i certificati di lavoro
tutti li conservavano perchè erano un po’ il curricolo
di ognuno. Alla fine di ogni stagione ne veniva assegnato uno…” “…
In Francia non esisteva la previdenza sociale, ma vi erano casse
che gravavano sul datore di lavoro e garantivano un pensione complementare,
bastava esibire i certificati di lavoro. E i certificati di lavoro
tutti li conservavano perchè erano un po’ il curricolo
di ognuno. Alla fine di ogni stagione ne veniva assegnato uno…”
|
|
| |
|
|
|